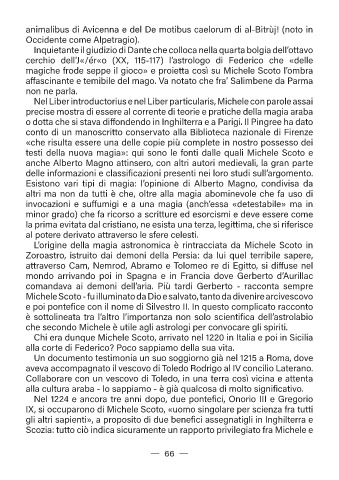Page 72 - Federico II - Genio dei tempi
P. 72
animalibus di Avicenna e del De motibus caelorum di al-Bitrùj! (noto in
Occidente come Alpetragio).
Inquietante il giudizio di Dante che colloca nella quarta bolgia dell’ottavo
cerchio dell’J«/ér«o (XX, 115-117) l’astrologo di Federico che «delle
magiche frode seppe il gioco» e proietta così su Michele Scoto l’ombra
affascinante e temibile del mago. Va notato che fra’ Salimbene da Parma
non ne parla.
Nel Liber introductorius e nel Liber particularis, Michele con parole assai
precise mostra di essere al corrente di teorie e pratiche della magia araba
o dotta che si stava diffondendo in Inghilterra e a Parigi. Il Pingree ha dato
conto di un manoscritto conservato alla Biblioteca nazionale di Firenze
«che risulta essere una delle copie più complete in nostro possesso dei
testi della nuova magia»: qui sono le fonti dalle quali Michele Scoto e
anche Alberto Magno attinsero, con altri autori medievali, la gran parte
delle informazioni e classificazioni presenti nei loro studi sull’argomento.
Esistono vari tipi di magia: l’opinione di Alberto Magno, condivisa da
altri ma non da tutti è che, oltre alla magia abominevole che fa uso di
invocazioni e suffumigi e a una magia (anch’essa «detestabile» ma in
minor grado) che fa ricorso a scritture ed esorcismi e deve essere come
la prima evitata dal cristiano, ne esista una terza, legittima, che si riferisce
al potere derivato attraverso le sfere celesti.
L’origine della magia astronomica è rintracciata da Michele Scoto in
Zoroastro, istruito dai demoni della Persia: da lui quel terribile sapere,
attraverso Cam, Nemrod, Abramo e Tolomeo re di Egitto, si diffuse nel
mondo arrivando poi in Spagna e in Francia dove Gerberto d’Aurillac
comandava ai demoni dell’aria. Più tardi Gerberto - racconta sempre
Michele Scoto - fu illuminato da Dio e salvato, tanto da divenire arcivescovo
e poi pontefice con il nome di Silvestro II. In questo complicato racconto
è sottolineata tra l’altro l’importanza non solo scientifica dell’astrolabio
che secondo Michele è utile agli astrologi per convocare gli spiriti.
Chi era dunque Michele Scoto, arrivato nel 1220 in Italia e poi in Sicilia
alla corte di Federico? Poco sappiamo della sua vita.
Un documento testimonia un suo soggiorno già nel 1215 a Roma, dove
aveva accompagnato il vescovo di Toledo Rodrigo al IV concilio Laterano.
Collaborare con un vescovo di Toledo, in una terra così vicina e attenta
alla cultura araba - lo sappiamo - è già qualcosa di molto significativo.
Nel 1224 e ancora tre anni dopo, due pontefici, Onorio III e Gregorio
IX, si occuparono di Michele Scoto, «uomo singolare per scienza fra tutti
gli altri sapienti», a proposito di due benefici assegnatigli in Inghilterra e
Scozia: tutto ciò indica sicuramente un rapporto privilegiato fra Michele e
— 66 —