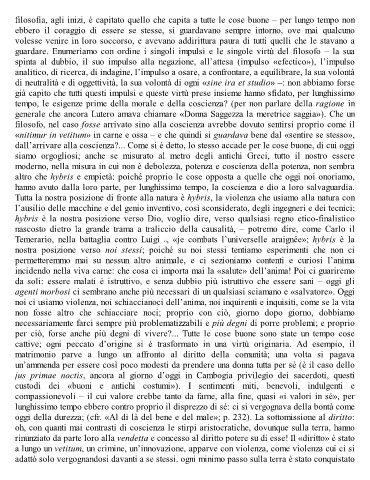Page 80 - Nietzsche - Genealogia della morale
P. 80
filosofia, agli inizi, è capitato quello che capita a tutte le cose buone – per lungo tempo non
ebbero il coraggio di essere se stesse, si guardavano sempre intorno, ove mai qualcuno
volesse venire in loro soccorso, e avevano addirittura paura di tutti quelli che le stavano a
guardare. Enumeriamo con ordine i singoli impulsi e le singole virtù del filosofo – la sua
spinta al dubbio, il suo impulso alla negazione, all’attesa (impulso «efectico»), l’impulso
analitico, di ricerca, di indagine, l’impulso a osare, a confrontare, a equilibrare, la sua volontà
di neutralità e di oggettività, la sua volontà di ogni «sine ira et studio» –: non abbiamo forse
già capito che tutti questi impulsi e queste virtù prese insieme hanno sfidato, per lunghissimo
tempo, le esigenze prime della morale e della coscienza? (per non parlare della ragione in
generale che ancora Lutero amava chiamare «Donna Saggezza la meretrice saggia»). Che un
filosofo, nel caso fosse arrivato sino alla coscienza avrebbe dovuto sentirsi proprio come il
«nitimur in vetitum» in carne e ossa – e che quindi si guardava bene dal «sentire se stesso»,
dall’arrivare alla coscienza?... Come si è detto, lo stesso accade per le cose buone, di cui oggi
siamo orgogliosi; anche se misurato al metro degli antichi Greci, tutto il nostro essere
moderno, nella misura in cui non è debolezza, potenza e coscienza della potenza, non sembra
altro che hybris e empietà: poiché proprio le cose opposta a quelle che oggi noi onoriamo,
hanno avuto dalla loro parte, per lunghissimo tempo, la coscienza e dio a loro salvaguardia.
Tutta la nostra posizione di fronte alla natura è hybris, la violenza che usiamo alla natura con
l’ausilio delle macchine e del genio inventivo, così sconsiderato, degli ingegneri e dei tecnici;
hybris è la nostra posizione verso Dio, voglio dire, verso qualsiasi regno etico-finalistico
nascosto dietro la grande trama a traliccio della causalità, – potremo dire, come Carlo il
Temerario, nella battaglia contro Luigi xi, «je combats l’universelle araignée»; hybris è la
nostra posizione verso noi stessi; poiché su noi stessi tentiamo esperimenti che non ci
permetteremmo mai su nessun altro animale, e ci sezioniamo contenti e curiosi l’anima
incidendo nella viva carne: che cosa ci importa mai la «salute» dell’anima! Poi ci guariremo
da soli: essere malati è istruttivo, e senza dubbio più istruttivo che essere sani – oggi gli
agenti morbosi ci sembrano anche più necessari di un qualsiasi sciamano e «salvatore». Oggi
noi ci usiamo violenza, noi schiaccianoci dell’anima, noi inquirenti e inquisiti, come se la vita
non fosse altro che schiacciare noci; proprio con ciò, giorno dopo giorno, dobbiamo
necessariamente farci sempre più problematizzabili e più degni di porre problemi; e proprio
per ciò, forse anche più degni di vivere?... Tutte le cose buone sono state un tempo cose
cattive; ogni peccato d’origine si è trasformato in una virtù originaria. Ad esempio, il
matrimonio parve a lungo un affronto al diritto della comunità; una volta si pagava
un’ammenda per essere così poco modesti da prendere una donna tutta per sé (è il caso dello
jus primae noctis, ancora al giorno d’oggi in Cambogia privilegio dei sacerdoti, questi
custodi dei «buoni e antichi costumi»). I sentimenti miti, benevoli, indulgenti e
compassionevoli – il cui valore crebbe tanto da farne, alla fine, quasi «i valori in sé», per
lunghissimo tempo ebbero contro proprio il disprezzo di sé: ci si vergognava della bontà come
oggi della durezza; (cfr. «Al di là del bene e del male»; p. 232). La sottomissione al diritto:
oh, con quanti mai contrasti di coscienza le stirpi aristocratiche, dovunque sulla terra, hanno
rinunziato da parte loro alla vendetta e concesso al diritto potere su di esse! Il «diritto» è stato
a lungo un vetitum, un crimine, un’innovazione, apparve con violenza, come violenza cui ci si
adattò solo vergognandosi davanti a se stessi. ogni minimo passo sulla terra è stato conquistato