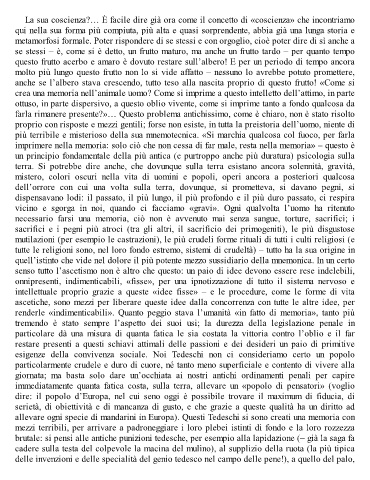Page 49 - Nietzsche - Genealogia della morale
P. 49
La sua coscienza?… È facile dire già ora come il concetto di «coscienza» che incontriamo
qui nella sua forma più compiuta, più alta e quasi sorprendente, abbia già una lunga storia e
metamorfosi formale. Poter rispondere di se stessi e con orgoglio, cioè poter dire di sì anche a
se stessi – è, come si è detto, un frutto maturo, ma anche un frutto tardo – per quanto tempo
questo frutto acerbo e amaro è dovuto restare sull’albero! E per un periodo di tempo ancora
molto più lungo questo frutto non lo si vide affatto – nessuno lo avrebbe potuto promettere,
anche se l’albero stava crescendo, tutto teso alla nascita proprio di questo frutto! «Come si
crea una memoria nell’animale uomo? Come si imprime a questo intelletto dell’attimo, in parte
ottuso, in parte dispersivo, a questo oblio vivente, come si imprime tanto a fondo qualcosa da
farla rimanere presente?»… Questo problema antichissimo, come è chiaro, non è stato risolto
proprio con risposte e mezzi gentili; forse non esiste, in tutta la preistoria dell’uomo, niente di
più terribile e misterioso della sua mnemotecnica. «Si marchia qualcosa col fuoco, per farla
imprimere nella memoria: solo ciò che non cessa di far male, resta nella memoria» – questo è
un principio fondamentale della più antica (e purtroppo anche più duratura) psicologia sulla
terra. Si potrebbe dire anche, che dovunque sulla terra esistano ancora solennità, gravità,
mistero, colori oscuri nella vita di uomini e popoli, operi ancora a posteriori qualcosa
dell’orrore con cui una volta sulla terra, dovunque, si prometteva, si davano pegni, si
dispensavano lodi: il passato, il più lungo, il più profondo e il più duro passato, ci respira
vicino e sgorga in noi, quando ci facciamo «gravi». Ogni qualvolta l’uomo ha ritenuto
necessario farsi una memoria, ciò non è avvenuto mai senza sangue, torture, sacrifici; i
sacrifici e i pegni più atroci (tra gli altri, il sacrificio dei primogeniti), le più disgustose
mutilazioni (per esempio le castrazioni), le più crudeli forme rituali di tutti i culti religiosi (e
tutte le religioni sono, nel loro fondo estremo, sistemi di crudeltà) – tutto ha la sua origine in
quell’istinto che vide nel dolore il più potente mezzo sussidiario della mnemonica. In un certo
senso tutto l’ascetismo non è altro che questo: un paio di idee devono essere rese indelebili,
onnipresenti, indimenticabili, «fisse», per una ipnotizzazione di tutto il sistema nervoso e
intellettuale proprio grazie a queste «idee fisse» – e le procedure, come le forme di vita
ascetiche, sono mezzi per liberare queste idee dalla concorrenza con tutte le altre idee, per
renderle «indimenticabili». Quanto peggio stava l’umanità «in fatto di memoria», tanto più
tremendo è stato sempre l’aspetto dei suoi usi; la durezza della legislazione penale in
particolare dà una misura di quanta fatica le sia costata la vittoria contro l’oblio e il far
restare presenti a questi schiavi attimali delle passioni e dei desideri un paio di primitive
esigenze della convivenza sociale. Noi Tedeschi non ci consideriamo certo un popolo
particolarmente crudele e duro di cuore, né tanto meno superficiale e contento di vivere alla
giornata; ma basta solo dare un’occhiata ai nostri antichi ordinamenti penali per capire
immediatamente quanta fatica costa, sulla terra, allevare un «popolo di pensatori» (voglio
dire: il popolo d’Europa, nel cui seno oggi è possibile trovare il maximum di fiducia, di
serietà, di obiettività e di mancanza di gusto, e che grazie a queste qualità ha un diritto ad
allevare ogni specie di mandarini in Europa). Questi Tedeschi si sono creati una memoria con
mezzi terribili, per arrivare a padroneggiare i loro plebei istinti di fondo e la loro rozzezza
brutale: si pensi alle antiche punizioni tedesche, per esempio alla lapidazione (– già la saga fa
cadere sulla testa del colpevole la macina del mulino), al supplizio della ruota (la più tipica
delle invenzioni e delle specialità del genio tedesco nel campo delle pene!), a quello del palo,