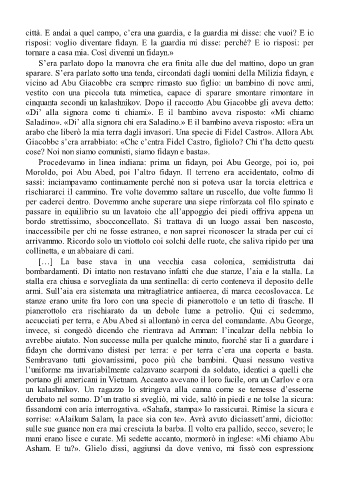Page 75 - Oriana Fallaci - La vita è una guerra ripetuta ogni giorno
P. 75
città. E andai a quel campo, c’era una guardia, e la guardia mi disse: che vuoi? E io
risposi: voglio diventare fidayn. E la guardia mi disse: perché? E io risposi: per
tornare a casa mia. Così divenni un fidayn.»
S’era parlato dopo la manovra che era finita alle due del mattino, dopo un gran
sparare. S’era parlato sotto una tenda, circondati dagli uomini della Milizia fidayn, e
vicino ad Abu Giacobbe era sempre rimasto suo figlio: un bambino di nove anni,
vestito con una piccola tuta mimetica, capace di sparare smontare rimontare in
cinquanta secondi un kalashnikov. Dopo il racconto Abu Giacobbe gli aveva detto:
«Di’ alla signora come ti chiami». E il bambino aveva risposto: «Mi chiamo
Saladino». «Di’ alla signora chi era Saladino.» E il bambino aveva risposto: «Era un
arabo che liberò la mia terra dagli invasori. Una specie di Fidel Castro». Allora Abu
Giacobbe s’era arrabbiato: «Che c’entra Fidel Castro, figliolo? Chi t’ha detto queste
cose? Noi non siamo comunisti, siamo fidayn e basta».
Procedevamo in linea indiana: prima un fidayn, poi Abu George, poi io, poi
Moroldo, poi Abu Abed, poi l’altro fidayn. Il terreno era accidentato, colmo di
sassi: inciampavamo continuamente perché non si poteva usar la torcia elettrica e
rischiararci il cammino. Tre volte dovemmo saltare un ruscello, due volte fummo lì
per caderci dentro. Dovemmo anche superare una siepe rinforzata col filo spinato e
passare in equilibrio su un lavatoio che all’appoggio dei piedi offriva appena un
bordo strettissimo, sbocconcellato. Si trattava di un luogo assai ben nascosto,
inaccessibile per chi ne fosse estraneo, e non saprei riconoscer la strada per cui ci
arrivammo. Ricordo solo un viottolo coi solchi delle ruote, che saliva ripido per una
collinetta, e un abbaiare di cani.
[…] La base stava in una vecchia casa colonica, semidistrutta dai
bombardamenti. Di intatto non restavano infatti che due stanze, l’aia e la stalla. La
stalla era chiusa e sorvegliata da una sentinella: di certo conteneva il deposito delle
armi. Sull’aia era sistemata una mitragliatrice antiaerea, di marca cecoslovacca. Le
stanze erano unite fra loro con una specie di pianerottolo e un tetto di frasche. Il
pianerottolo era rischiarato da un debole lume a petrolio. Qui ci sedemmo,
accucciati per terra, e Abu Abed si allontanò in cerca del comandante. Abu George,
invece, si congedò dicendo che rientrava ad Amman: l’incalzar della nebbia lo
avrebbe aiutato. Non successe nulla per qualche minuto, fuorché star lì a guardare i
fidayn che dormivano distesi per terra: e per terra c’era una coperta e basta.
Sembravano tutti giovanissimi, poco più che bambini. Quasi nessuno vestiva
l’uniforme ma invariabilmente calzavano scarponi da soldato, identici a quelli che
portano gli americani in Vietnam. Accanto avevano il loro fucile, ora un Carlov e ora
un kalashnikov. Un ragazzo lo stringeva alla canna come se temesse d’esserne
derubato nel sonno. D’un tratto si svegliò, mi vide, saltò in piedi e ne tolse la sicura:
fissandomi con aria interrogativa. «Sahafa, stampa» lo rassicurai. Rimise la sicura e
sorrise: «Alaikum Salam, la pace sia con te». Avrà avuto diciassett’anni, diciotto:
sulle sue guance non era mai cresciuta la barba. Il volto era pallido, secco, severo; le
mani erano lisce e curate. Mi sedette accanto, mormorò in inglese: «Mi chiamo Abu
Asham. E tu?». Glielo dissi, aggiunsi da dove venivo, mi fissò con espressione