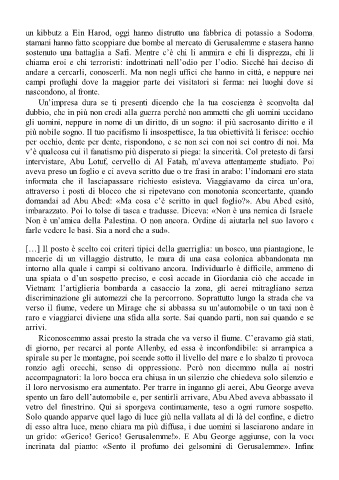Page 71 - Oriana Fallaci - La vita è una guerra ripetuta ogni giorno
P. 71
un kibbutz a Ein Harod, oggi hanno distrutto una fabbrica di potassio a Sodoma,
stamani hanno fatto scoppiare due bombe al mercato di Gerusalemme e stasera hanno
sostenuto una battaglia a Safi. Mentre c’è chi li ammira e chi li disprezza, chi li
chiama eroi e chi terroristi: indottrinati nell’odio per l’odio. Sicché hai deciso di
andare a cercarli, conoscerli. Ma non negli uffici che hanno in città, e neppure nei
campi profughi dove la maggior parte dei visitatori si ferma: nei luoghi dove si
nascondono, al fronte.
Un’impresa dura se ti presenti dicendo che la tua coscienza è sconvolta dal
dubbio, che in più non credi alla guerra perché non ammetti che gli uomini uccidano
gli uomini, neppure in nome di un diritto, di un sogno: il più sacrosanto diritto e il
più nobile sogno. Il tuo pacifismo li insospettisce, la tua obiettività li ferisce: occhio
per occhio, dente per dente, rispondono, e se non sei con noi sei contro di noi. Ma
v’è qualcosa cui il fanatismo più disperato si piega: la sincerità. Col pretesto di farsi
intervistare, Abu Lotuf, cervello di Al Fatah, m’aveva attentamente studiato. Poi
aveva preso un foglio e ci aveva scritto due o tre frasi in arabo: l’indomani ero stata
informata che il lasciapassare richiesto esisteva. Viaggiavamo da circa un’ora,
attraverso i posti di blocco che si ripetevano con monotonia sconcertante, quando
domandai ad Abu Abed: «Ma cosa c’è scritto in quel foglio?». Abu Abed esitò,
imbarazzato. Poi lo tolse di tasca e tradusse. Diceva: «Non è una nemica di Israele.
Non è un’amica della Palestina. O non ancora. Ordine di aiutarla nel suo lavoro e
farle vedere le basi. Sia a nord che a sud».
[…] Il posto è scelto coi criteri tipici della guerriglia: un bosco, una piantagione, le
macerie di un villaggio distrutto, le mura di una casa colonica abbandonata ma
intorno alla quale i campi si coltivano ancora. Individuarlo è difficile, ammeno di
una spiata o d’un sospetto preciso, e così accade in Giordania ciò che accade in
Vietnam: l’artiglieria bombarda a casaccio la zona, gli aerei mitragliano senza
discriminazione gli automezzi che la percorrono. Soprattutto lungo la strada che va
verso il fiume, vedere un Mirage che si abbassa su un’automobile o un taxi non è
raro e viaggiarci diviene una sfida alla sorte. Sai quando parti, non sai quando e se
arrivi.
Riconoscemmo assai presto la strada che va verso il fiume. C’eravamo già stati,
di giorno, per recarci al ponte Allenby, ed essa è inconfondibile: si arrampica a
spirale su per le montagne, poi scende sotto il livello del mare e lo sbalzo ti provoca
ronzio agli orecchi, senso di oppressione. Però non dicemmo nulla ai nostri
accompagnatori: la loro bocca era chiusa in un silenzio che chiedeva solo silenzio e
il loro nervosismo era aumentato. Per trarre in inganno gli aerei, Abu George aveva
spento un faro dell’automobile e, per sentirli arrivare, Abu Abed aveva abbassato il
vetro del finestrino. Qui si sporgeva continuamente, teso a ogni rumore sospetto.
Solo quando apparve quel lago di luce giù nella vallata al di là del confine, e dietro
di esso altra luce, meno chiara ma più diffusa, i due uomini si lasciarono andare in
un grido: «Gerico! Gerico! Gerusalemme!». E Abu George aggiunse, con la voce
incrinata dal pianto: «Sento il profumo dei gelsomini di Gerusalemme». Infine