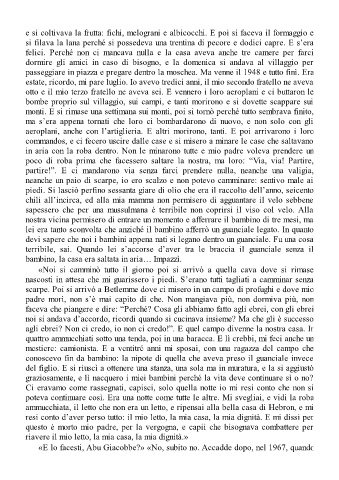Page 73 - Oriana Fallaci - La vita è una guerra ripetuta ogni giorno
P. 73
e si coltivava la frutta: fichi, melograni e albicocchi. E poi si faceva il formaggio e
si filava la lana perché si possedeva una trentina di pecore e dodici capre. E s’era
felici. Perché non ci mancava nulla e la casa aveva anche tre camere per farci
dormire gli amici in caso di bisogno, e la domenica si andava al villaggio per
passeggiare in piazza e pregare dentro la moschea. Ma venne il 1948 e tutto finì. Era
estate, ricordo, mi pare luglio. Io avevo tredici anni, il mio secondo fratello ne aveva
otto e il mio terzo fratello ne aveva sei. E vennero i loro aeroplani e ci buttaron le
bombe proprio sul villaggio, sui campi, e tanti morirono e si dovette scappare sui
monti. E si rimase una settimana sui monti, poi si tornò perché tutto sembrava finito,
ma s’era appena tornati che loro ci bombardarono di nuovo, e non solo con gli
aeroplani, anche con l’artiglieria. E altri morirono, tanti. E poi arrivarono i loro
commandos, e ci fecero uscire dalle case e si misero a minare le case che saltavano
in aria con la roba dentro. Non le minarono tutte e mio padre voleva prendere un
poco di roba prima che facessero saltare la nostra, ma loro: “Via, via! Partire,
partire!”. E ci mandarono via senza farci prendere nulla, neanche una valigia,
neanche un paio di scarpe, io ero scalzo e non potevo camminare: sentivo male ai
piedi. Si lasciò perfino sessanta giare di olio che era il raccolto dell’anno, seicento
chili all’incirca, ed alla mia mamma non permisero di agguantare il velo sebbene
sapessero che per una mussulmana è terribile non coprirsi il viso col velo. Alla
nostra vicina permisero di entrare un momento e afferrare il bambino di tre mesi, ma
lei era tanto sconvolta che anziché il bambino afferrò un guanciale legato. In quanto
devi sapere che noi i bambini appena nati si legano dentro un guanciale. Fu una cosa
terribile, sai. Quando lei s’accorse d’aver tra le braccia il guanciale senza il
bambino, la casa era saltata in aria… Impazzì.
«Noi si camminò tutto il giorno poi si arrivò a quella cava dove si rimase
nascosti in attesa che mi guarissero i piedi. S’erano tutti tagliati a camminar senza
scarpe. Poi si arrivò a Betlemme dove ci misero in un campo di profughi e dove mio
padre morì, non s’è mai capito di che. Non mangiava più, non dormiva più, non
faceva che piangere e dire: “Perché? Cosa gli abbiamo fatto agli ebrei, con gli ebrei
noi si andava d’accordo, ricordi quando si cucinava insieme? Ma che gli è successo
agli ebrei? Non ci credo, io non ci credo!”. E quel campo divenne la nostra casa. In
quattro ammucchiati sotto una tenda, poi in una baracca. E lì crebbi, mi feci anche un
mestiere: camionista. E a ventitré anni mi sposai, con una ragazza del campo che
conoscevo fin da bambino: la nipote di quella che aveva preso il guanciale invece
del figlio. E si riuscì a ottenere una stanza, una sola ma in muratura, e la si aggiustò
graziosamente, e lì nacquero i miei bambini perché la vita deve continuare sì o no?
Ci eravamo come rassegnati, capisci, solo quella notte io mi resi conto che non si
poteva continuare così. Era una notte come tutte le altre. Mi svegliai, e vidi la roba
ammucchiata, il letto che non era un letto, e ripensai alla bella casa di Hebron, e mi
resi conto d’aver perso tutto: il mio letto, la mia casa, la mia dignità. E mi dissi per
questo è morto mio padre, per la vergogna, e capii che bisognava combattere per
riavere il mio letto, la mia casa, la mia dignità.»
«E lo facesti, Abu Giacobbe?» «No, subito no. Accadde dopo, nel 1967, quando