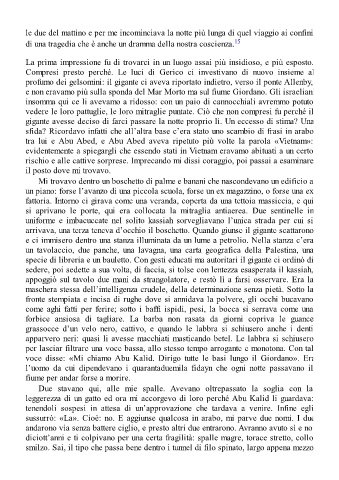Page 78 - Oriana Fallaci - La vita è una guerra ripetuta ogni giorno
P. 78
le due del mattino e per me incominciava la notte più lunga di quel viaggio ai confini
di una tragedia che è anche un dramma della nostra coscienza. 15
La prima impressione fu di trovarci in un luogo assai più insidioso, e più esposto.
Compresi presto perché. Le luci di Gerico ci investivano di nuovo insieme al
profumo dei gelsomini: il gigante ci aveva riportato indietro, verso il ponte Allenby,
e non eravamo più sulla sponda del Mar Morto ma sul fiume Giordano. Gli israeliani
insomma qui ce li avevamo a ridosso: con un paio di cannocchiali avremmo potuto
vedere le loro pattuglie, le loro mitraglie puntate. Ciò che non compresi fu perché il
gigante avesse deciso di farci passare la notte proprio lì. Un eccesso di stima? Una
sfida? Ricordavo infatti che all’altra base c’era stato uno scambio di frasi in arabo
tra lui e Abu Abed, e Abu Abed aveva ripetuto più volte la parola «Vietnam»:
evidentemente a spiegargli che essendo stati in Vietnam eravamo abituati a un certo
rischio e alle cattive sorprese. Imprecando mi dissi coraggio, poi passai a esaminare
il posto dove mi trovavo.
Mi trovavo dentro un boschetto di palme e banani che nascondevano un edificio a
un piano: forse l’avanzo di una piccola scuola, forse un ex magazzino, o forse una ex
fattoria. Intorno ci girava come una veranda, coperta da una tettoia massiccia, e qui
si aprivano le porte, qui era collocata la mitraglia antiaerea. Due sentinelle in
uniforme e imbacuccate nel solito kassiah sorvegliavano l’unica strada per cui si
arrivava, una terza teneva d’occhio il boschetto. Quando giunse il gigante scattarono
e ci immisero dentro una stanza illuminata da un lume a petrolio. Nella stanza c’era
un tavolaccio, due panche, una lavagna, una carta geografica della Palestina, una
specie di libreria e un bauletto. Con gesti educati ma autoritari il gigante ci ordinò di
sedere, poi sedette a sua volta, di faccia, si tolse con lentezza esasperata il kassiah,
appoggiò sul tavolo due mani da strangolatore, e restò lì a farsi osservare. Era la
maschera stessa dell’intelligenza crudele, della determinazione senza pietà. Sotto la
fronte stempiata e incisa di rughe dove si annidava la polvere, gli occhi bucavano
come aghi fatti per ferire; sotto i baffi ispidi, pesi, la bocca si serrava come una
forbice ansiosa di tagliare. La barba non rasata da giorni copriva le guance
grassocce d’un velo nero, cattivo, e quando le labbra si schiusero anche i denti
apparvero neri: quasi li avesse macchiati masticando betel. Le labbra si schiusero
per lasciar filtrare una voce bassa, allo stesso tempo arrogante e monotona. Con tal
voce disse: «Mi chiamo Abu Kalid. Dirigo tutte le basi lungo il Giordano». Era
l’uomo da cui dipendevano i quarantaduemila fidayn che ogni notte passavano il
fiume per andar forse a morire.
Due stavano qui, alle mie spalle. Avevano oltrepassato la soglia con la
leggerezza di un gatto ed ora mi accorgevo di loro perché Abu Kalid li guardava:
tenendoli sospesi in attesa di un’approvazione che tardava a venire. Infine egli
sussurrò: «La». Cioè: no. E aggiunse qualcosa in arabo, mi parve due nomi. I due
andarono via senza battere ciglio, e presto altri due entrarono. Avranno avuto sì e no
diciott’anni e ti colpivano per una certa fragilità: spalle magre, torace stretto, collo
smilzo. Sai, il tipo che passa bene dentro i tunnel di filo spinato, largo appena mezzo