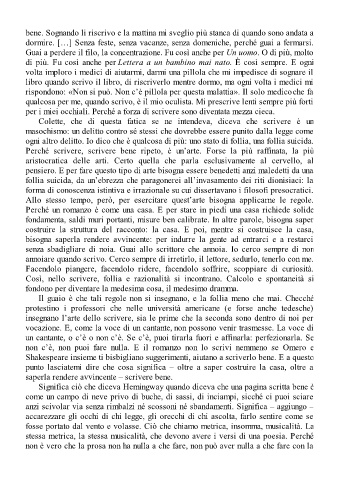Page 130 - Oriana Fallaci - Solo io posso scrivere la mia storia
P. 130
bene. Sognando li riscrivo e la mattina mi sveglio più stanca di quando sono andata a
dormire. […] Senza feste, senza vacanze, senza domeniche, perché guai a fermarsi.
Guai a perdere il filo, la concentrazione. Fu così anche per Un uomo. O di più, molto
di più. Fu così anche per Lettera a un bambino mai nato. È così sempre. E ogni
volta imploro i medici di aiutarmi, darmi una pillola che mi impedisce di sognare il
libro quando scrivo il libro, di riscriverlo mentre dormo, ma ogni volta i medici mi
rispondono: «Non si può. Non c’è pillola per questa malattia». Il solo medico che fa
qualcosa per me, quando scrivo, è il mio oculista. Mi prescrive lenti sempre più forti
per i miei occhiali. Perché a forza di scrivere sono diventata mezza cieca.
Colette, che di questa fatica se ne intendeva, diceva che scrivere è un
masochismo: un delitto contro sé stessi che dovrebbe essere punito dalla legge come
ogni altro delitto. Io dico che è qualcosa di più: uno stato di follia, una follia suicida.
Perché scrivere, scrivere bene ripeto, è un’arte. Forse la più raffinata, la più
aristocratica delle arti. Certo quella che parla esclusivamente al cervello, al
pensiero. E per fare questo tipo di arte bisogna essere benedetti anzi maledetti da una
follia suicida, da un’ebrezza che paragonerei all’invasamento dei riti dionisiaci: la
forma di conoscenza istintiva e irrazionale su cui dissertavano i filosofi presocratici.
Allo stesso tempo, però, per esercitare quest’arte bisogna applicarne le regole.
Perché un romanzo è come una casa. E per stare in piedi una casa richiede solide
fondamenta, saldi muri portanti, misure ben calibrate. In altre parole, bisogna saper
costruire la struttura del racconto: la casa. E poi, mentre si costruisce la casa,
bisogna saperla rendere avvincente: per indurre la gente ad entrarci e a restarci
senza sbadigliare di noia. Guai allo scrittore che annoia. Io cerco sempre di non
annoiare quando scrivo. Cerco sempre di irretirlo, il lettore, sedurlo, tenerlo con me.
Facendolo piangere, facendolo ridere, facendolo soffrire, scoppiare di curiosità.
Così, nello scrivere, follia e razionalità si incontrano. Calcolo e spontaneità si
fondono per diventare la medesima cosa, il medesimo dramma.
Il guaio è che tali regole non si insegnano, e la follia meno che mai. Checché
protestino i professori che nelle università americane (e forse anche tedesche)
insegnano l’arte dello scrivere, sia le prime che la seconda sono dentro di noi per
vocazione. E, come la voce di un cantante, non possono venir trasmesse. La voce di
un cantante, o c’è o non c’è. Se c’è, puoi tirarla fuori e affinarla: perfezionarla. Se
non c’è, non puoi fare nulla. E il romanzo non lo scrivi nemmeno se Omero e
Shakespeare insieme ti bisbigliano suggerimenti, aiutano a scriverlo bene. E a questo
punto lasciatemi dire che cosa significa – oltre a saper costruire la casa, oltre a
saperla rendere avvincente – scrivere bene.
Significa ciò che diceva Hemingway quando diceva che una pagina scritta bene è
come un campo di neve privo di buche, di sassi, di inciampi, sicché ci puoi sciare
anzi scivolar via senza rimbalzi né scossoni né sbandamenti. Significa – aggiungo –
accarezzare gli occhi di chi legge, gli orecchi di chi ascolta, farlo sentire come se
fosse portato dal vento e volasse. Ciò che chiamo metrica, insomma, musicalità. La
stessa metrica, la stessa musicalità, che devono avere i versi di una poesia. Perché
non è vero che la prosa non ha nulla a che fare, non può aver nulla a che fare con la