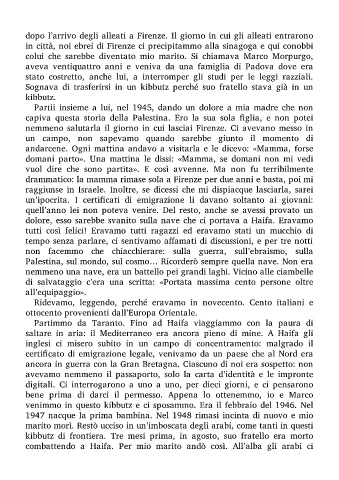Page 227 - Oriana Fallaci - Le radici dell'odio. La mia verità sull'Islam
P. 227
dopo l’arrivo degli alleati a Firenze. Il giorno in cui gli alleati entrarono
in città, noi ebrei di Firenze ci precipitammo alla sinagoga e qui conobbi
colui che sarebbe diventato mio marito. Si chiamava Marco Morpurgo,
aveva ventiquattro anni e veniva da una famiglia di Padova dove era
stato costretto, anche lui, a interromper gli studi per le leggi razziali.
Sognava di trasferirsi in un kibbutz perché suo fratello stava già in un
kibbutz.
Partii insieme a lui, nel 1945, dando un dolore a mia madre che non
capiva questa storia della Palestina. Ero la sua sola glia, e non potei
nemmeno salutarla il giorno in cui lasciai Firenze. Ci avevano messo in
un campo, non sapevamo quando sarebbe giunto il momento di
andarcene. Ogni mattina andavo a visitarla e le dicevo: «Mamma, forse
domani parto». Una mattina le dissi: «Mamma, se domani non mi vedi
vuol dire che sono partita». E così avvenne. Ma non fu terribilmente
drammatico: la mamma rimase sola a Firenze per due anni e basta, poi mi
raggiunse in Israele. Inoltre, se dicessi che mi dispiacque lasciarla, sarei
un’ipocrita. I certi cati di emigrazione li davano soltanto ai giovani:
quell’anno lei non poteva venire. Del resto, anche se avessi provato un
dolore, esso sarebbe svanito sulla nave che ci portava a Haifa. Eravamo
tutti così felici! Eravamo tutti ragazzi ed eravamo stati un mucchio di
tempo senza parlare, ci sentivamo a amati di discussioni, e per tre notti
non facemmo che chiacchierare: sulla guerra, sull’ebraismo, sulla
Palestina, sul mondo, sul cosmo… Ricorderò sempre quella nave. Non era
nemmeno una nave, era un battello pei grandi laghi. Vicino alle ciambelle
di salvataggio c’era una scritta: «Portata massima cento persone oltre
all’equipaggio».
Ridevamo, leggendo, perché eravamo in novecento. Cento italiani e
ottocento provenienti dall’Europa Orientale.
Partimmo da Taranto. Fino ad Haifa viaggiammo con la paura di
saltare in aria: il Mediterraneo era ancora pieno di mine. A Haifa gli
inglesi ci misero subito in un campo di concentramento: malgrado il
certi cato di emigrazione legale, venivamo da un paese che al Nord era
ancora in guerra con la Gran Bretagna. Ciascuno di noi era sospetto: non
avevamo nemmeno il passaporto, solo la carta d’identità e le impronte
digitali. Ci interrogarono a uno a uno, per dieci giorni, e ci pensarono
bene prima di darci il permesso. Appena lo ottenemmo, io e Marco
venimmo in questo kibbutz e ci sposammo. Era il febbraio del 1946. Nel
1947 nacque la prima bambina. Nel 1948 rimasi incinta di nuovo e mio
marito morì. Restò ucciso in un’imboscata degli arabi, come tanti in questi
kibbutz di frontiera. Tre mesi prima, in agosto, suo fratello era morto
combattendo a Haifa. Per mio marito andò così. All’alba gli arabi ci