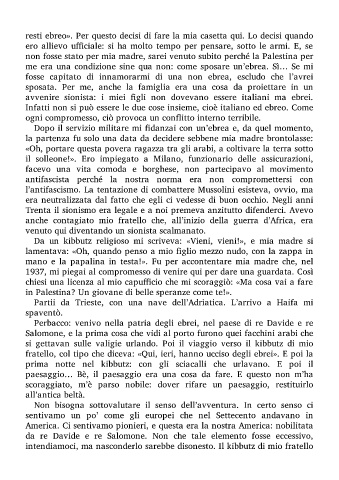Page 224 - Oriana Fallaci - Le radici dell'odio. La mia verità sull'Islam
P. 224
resti ebreo». Per questo decisi di fare la mia casetta qui. Lo decisi quando
ero allievo u ciale: si ha molto tempo per pensare, sotto le armi. E, se
non fosse stato per mia madre, sarei venuto subito perché la Palestina per
me era una condizione sine qua non: come sposare un’ebrea. Sì… Se mi
fosse capitato di innamorarmi di una non ebrea, escludo che l’avrei
sposata. Per me, anche la famiglia era una cosa da proiettare in un
avvenire sionista: i miei gli non dovevano essere italiani ma ebrei.
Infatti non si può essere le due cose insieme, cioè italiano ed ebreo. Come
ogni compromesso, ciò provoca un conflitto interno terribile.
Dopo il servizio militare mi danzai con un’ebrea e, da quel momento,
la partenza fu solo una data da decidere sebbene mia madre brontolasse:
«Oh, portare questa povera ragazza tra gli arabi, a coltivare la terra sotto
il solleone!». Ero impiegato a Milano, funzionario delle assicurazioni,
facevo una vita comoda e borghese, non partecipavo al movimento
antifascista perché la nostra norma era non compromettersi con
l’antifascismo. La tentazione di combattere Mussolini esisteva, ovvio, ma
era neutralizzata dal fatto che egli ci vedesse di buon occhio. Negli anni
Trenta il sionismo era legale e a noi premeva anzitutto difenderci. Avevo
anche contagiato mio fratello che, all’inizio della guerra d’Africa, era
venuto qui diventando un sionista scalmanato.
Da un kibbutz religioso mi scriveva: «Vieni, vieni!», e mia madre si
lamentava: «Oh, quando penso a mio glio mezzo nudo, con la zappa in
mano e la papalina in testa!». Fu per accontentare mia madre che, nel
1937, mi piegai al compromesso di venire qui per dare una guardata. Così
chiesi una licenza al mio capu cio che mi scoraggiò: «Ma cosa vai a fare
in Palestina? Un giovane di belle speranze come te!».
Partii da Trieste, con una nave dell’Adriatica. L’arrivo a Haifa mi
spaventò.
Perbacco: venivo nella patria degli ebrei, nel paese di re Davide e re
Salomone, e la prima cosa che vidi al porto furono quei facchini arabi che
si gettavan sulle valigie urlando. Poi il viaggio verso il kibbutz di mio
fratello, col tipo che diceva: «Qui, ieri, hanno ucciso degli ebrei». E poi la
prima notte nel kibbutz: con gli sciacalli che urlavano. E poi il
paesaggio… Bè, il paesaggio era una cosa da fare. E questo non m’ha
scoraggiato, m’è parso nobile: dover rifare un paesaggio, restituirlo
all’antica beltà.
Non bisogna sottovalutare il senso dell’avventura. In certo senso ci
sentivamo un po’ come gli europei che nel Settecento andavano in
America. Ci sentivamo pionieri, e questa era la nostra America: nobilitata
da re Davide e re Salomone. Non che tale elemento fosse eccessivo,
intendiamoci, ma nasconderlo sarebbe disonesto. Il kibbutz di mio fratello