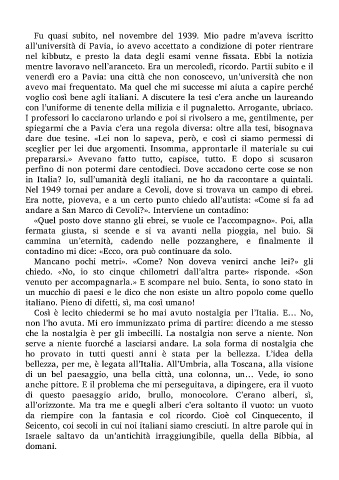Page 213 - Oriana Fallaci - Le radici dell'odio. La mia verità sull'Islam
P. 213
Fu quasi subito, nel novembre del 1939. Mio padre m’aveva iscritto
all’università di Pavia, io avevo accettato a condizione di poter rientrare
nel kibbutz, e presto la data degli esami venne ssata. Ebbi la notizia
mentre lavoravo nell’aranceto. Era un mercoledì, ricordo. Partii subito e il
venerdì ero a Pavia: una città che non conoscevo, un’università che non
avevo mai frequentato. Ma quel che mi successe mi aiuta a capire perché
voglio così bene agli italiani. A discutere la tesi c’era anche un laureando
con l’uniforme di tenente della milizia e il pugnaletto. Arrogante, ubriaco.
I professori lo cacciarono urlando e poi si rivolsero a me, gentilmente, per
spiegarmi che a Pavia c’era una regola diversa: oltre alla tesi, bisognava
dare due tesine. «Lei non lo sapeva, però, e così ci siamo permessi di
sceglier per lei due argomenti. Insomma, approntarle il materiale su cui
prepararsi.» Avevano fatto tutto, capisce, tutto. E dopo si scusaron
per no di non potermi dare centodieci. Dove accadono certe cose se non
in Italia? Io, sull’umanità degli italiani, ne ho da raccontare a quintali.
Nel 1949 tornai per andare a Cevoli, dove si trovava un campo di ebrei.
Era notte, pioveva, e a un certo punto chiedo all’autista: «Come si fa ad
andare a San Marco di Cevoli?». Interviene un contadino:
«Quel posto dove stanno gli ebrei, se vuole ce l’accompagno». Poi, alla
fermata giusta, si scende e si va avanti nella pioggia, nel buio. Si
cammina un’eternità, cadendo nelle pozzanghere, e nalmente il
contadino mi dice: «Ecco, ora può continuare da solo.
Mancano pochi metri». «Come? Non doveva venirci anche lei?» gli
chiedo. «No, io sto cinque chilometri dall’altra parte» risponde. «Son
venuto per accompagnarla.» E scompare nel buio. Senta, io sono stato in
un mucchio di paesi e le dico che non esiste un altro popolo come quello
italiano. Pieno di difetti, sì, ma così umano!
Così è lecito chiedermi se ho mai avuto nostalgia per l’Italia. E… No,
non l’ho avuta. Mi ero immunizzato prima di partire: dicendo a me stesso
che la nostalgia è per gli imbecilli. La nostalgia non serve a niente. Non
serve a niente fuorché a lasciarsi andare. La sola forma di nostalgia che
ho provato in tutti questi anni è stata per la bellezza. L’idea della
bellezza, per me, è legata all’Italia. All’Umbria, alla Toscana, alla visione
di un bel paesaggio, una bella città, una colonna, un… Vede, io sono
anche pittore. E il problema che mi perseguitava, a dipingere, era il vuoto
di questo paesaggio arido, brullo, monocolore. C’erano alberi, sì,
all’orizzonte. Ma tra me e quegli alberi c’era soltanto il vuoto: un vuoto
da riempire con la fantasia e col ricordo. Cioè col Cinquecento, il
Seicento, coi secoli in cui noi italiani siamo cresciuti. In altre parole qui in
Israele saltavo da un’antichità irraggiungibile, quella della Bibbia, al
domani.