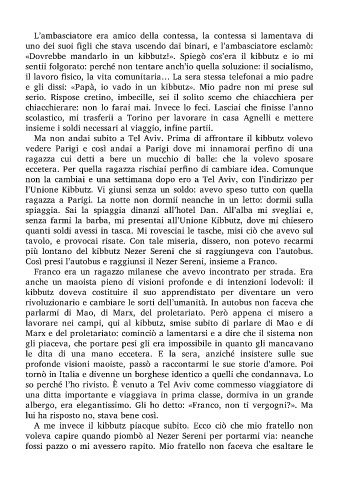Page 207 - Oriana Fallaci - Le radici dell'odio. La mia verità sull'Islam
P. 207
L’ambasciatore era amico della contessa, la contessa si lamentava di
uno dei suoi gli che stava uscendo dai binari, e l’ambasciatore esclamò:
«Dovrebbe mandarlo in un kibbutz!». Spiegò cos’era il kibbutz e io mi
sentii folgorato: perché non tentare anch’io quella soluzione: il socialismo,
il lavoro sico, la vita comunitaria… La sera stessa telefonai a mio padre
e gli dissi: «Papà, io vado in un kibbutz». Mio padre non mi prese sul
serio. Rispose cretino, imbecille, sei il solito scemo che chiacchiera per
chiacchierare: non lo farai mai. Invece lo feci. Lasciai che nisse l’anno
scolastico, mi trasferii a Torino per lavorare in casa Agnelli e mettere
insieme i soldi necessari al viaggio, infine partii.
Ma non andai subito a Tel Aviv. Prima di a rontare il kibbutz volevo
vedere Parigi e così andai a Parigi dove mi innamorai per no di una
ragazza cui detti a bere un mucchio di balle: che la volevo sposare
eccetera. Per quella ragazza rischiai per no di cambiare idea. Comunque
non la cambiai e una settimana dopo ero a Tel Aviv, con l’indirizzo per
l’Unione Kibbutz. Vi giunsi senza un soldo: avevo speso tutto con quella
ragazza a Parigi. La notte non dormii neanche in un letto: dormii sulla
spiaggia. Sai la spiaggia dinanzi all’hotel Dan. All’alba mi svegliai e,
senza farmi la barba, mi presentai all’Unione Kibbutz, dove mi chiesero
quanti soldi avessi in tasca. Mi rovesciai le tasche, misi ciò che avevo sul
tavolo, e provocai risate. Con tale miseria, dissero, non potevo recarmi
più lontano del kibbutz Nezer Sereni che si raggiungeva con l’autobus.
Così presi l’autobus e raggiunsi il Nezer Sereni, insieme a Franco.
Franco era un ragazzo milanese che avevo incontrato per strada. Era
anche un maoista pieno di visioni profonde e di intenzioni lodevoli: il
kibbutz doveva costituire il suo apprendistato per diventare un vero
rivoluzionario e cambiare le sorti dell’umanità. In autobus non faceva che
parlarmi di Mao, di Marx, del proletariato. Però appena ci misero a
lavorare nei campi, qui al kibbutz, smise subito di parlare di Mao e di
Marx e del proletariato: cominciò a lamentarsi e a dire che il sistema non
gli piaceva, che portare pesi gli era impossibile in quanto gli mancavano
le dita di una mano eccetera. E la sera, anziché insistere sulle sue
profonde visioni maoiste, passò a raccontarmi le sue storie d’amore. Poi
tornò in Italia e divenne un borghese identico a quelli che condannava. Lo
so perché l’ho rivisto. È venuto a Tel Aviv come commesso viaggiatore di
una ditta importante e viaggiava in prima classe, dormiva in un grande
albergo, era elegantissimo. Gli ho detto: «Franco, non ti vergogni?». Ma
lui ha risposto no, stava bene così.
A me invece il kibbutz piacque subito. Ecco ciò che mio fratello non
voleva capire quando piombò al Nezer Sereni per portarmi via: neanche
fossi pazzo o mi avessero rapito. Mio fratello non faceva che esaltare le