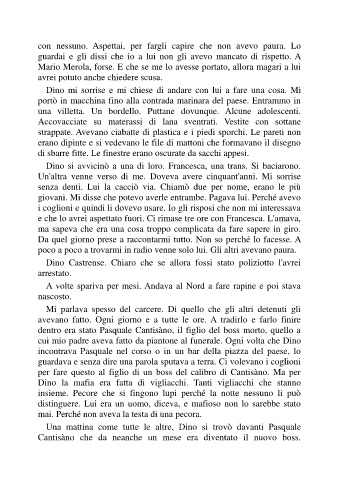Page 12 - Sbirritudine
P. 12
con nessuno. Aspettai, per fargli capire che non avevo paura. Lo
guardai e gli dissi che io a lui non gli avevo mancato di rispetto. A
Mario Merola, forse. E che se me lo avesse portato, allora magari a lui
avrei potuto anche chiedere scusa.
Dino mi sorrise e mi chiese di andare con lui a fare una cosa. Mi
portò in macchina fino alla contrada marinara del paese. Entrammo in
una villetta. Un bordello. Puttane dovunque. Alcune adolescenti.
Accovacciate su materassi di lana sventrati. Vestite con sottane
strappate. Avevano ciabatte di plastica e i piedi sporchi. Le pareti non
erano dipinte e si vedevano le file di mattoni che formavano il disegno
di sbarre fitte. Le finestre erano oscurate da sacchi appesi.
Dino si avvicinò a una di loro. Francesca, una trans. Si baciarono.
Un'altra venne verso di me. Doveva avere cinquant'anni. Mi sorrise
senza denti. Lui la cacciò via. Chiamò due per nome, erano le più
giovani. Mi disse che potevo averle entrambe. Pagava lui. Perché avevo
i coglioni e quindi li dovevo usare. Io gli risposi che non mi interessava
e che lo avrei aspettato fuori. Ci rimase tre ore con Francesca. L'amava,
ma sapeva che era una cosa troppo complicata da fare sapere in giro.
Da quel giorno prese a raccontarmi tutto. Non so perché lo facesse. A
poco a poco a trovarmi in radio venne solo lui. Gli altri avevano paura.
Dino Castrense. Chiaro che se allora fossi stato poliziotto l'avrei
arrestato.
A volte spariva per mesi. Andava al Nord a fare rapine e poi stava
nascosto.
Mi parlava spesso del carcere. Di quello che gli altri detenuti gli
avevano fatto. Ogni giorno e a tutte le ore. A tradirlo e farlo finire
dentro era stato Pasquale Cantisàno, il figlio del boss morto, quello a
cui mio padre aveva fatto da piantone al funerale. Ogni volta che Dino
incontrava Pasquale nel corso o in un bar della piazza del paese, lo
guardava e senza dire una parola sputava a terra. Ci volevano i coglioni
per fare questo al figlio di un boss del calibro di Cantisàno. Ma per
Dino la mafia era fatta di vigliacchi. Tanti vigliacchi che stanno
insieme. Pecore che si fingono lupi perché la notte nessuno li può
distinguere. Lui era un uomo, diceva, e mafioso non lo sarebbe stato
mai. Perché non aveva la testa di una pecora.
Una mattina come tutte le altre, Dino si trovò davanti Pasquale
Cantisàno che da neanche un mese era diventato il nuovo boss.