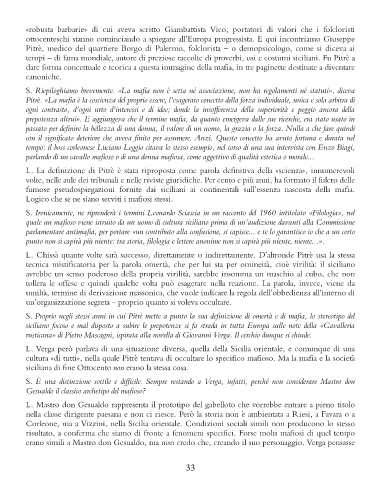Page 33 - Potere criminale
P. 33
«robusta barbarie» di cui aveva scritto Giambattista Vico, portatori di valori che i folcloristi
ottocenteschi stanno cominciando a spiegare all’Europa progressista. E qui incontriamo Giuseppe
Pitrè, medico del quartiere Borgo di Palermo, folclorista – o demopsicologo, come si diceva ai
tempi – di fama mondiale, autore di preziose raccolte di proverbi, usi e costumi siciliani. Fu Pitrè a
dare forma concettuale e teorica a questa immagine della mafia, in tre paginette destinate a diventare
canoniche.
S. Riepiloghiamo brevemente. «La mafia non è setta né associazione, non ha regolamenti né statuti», diceva
Pitrè. «La mafia è la coscienza del proprio essere, l’esagerato concetto della forza individuale, unica e sola arbitra di
ogni contrasto, d’ogni urto d’interessi e di idee; donde la insofferenza della superiorità e peggio ancora della
prepotenza altrui». E aggiungeva che il termine mafia, da quanto emergeva dalle sue ricerche, era stato usato in
passato per definire la bellezza di una donna, il valore di un uomo, la grazia o la forza. Nulla a che fare quindi
con il significato deteriore che aveva finito per assumere. Anzi. Questo concetto ha avuto fortuna e durata nel
tempo: il boss corleonese Luciano Leggio citava lo stesso esempio, nel corso di una sua intervista con Enzo Biagi,
parlando di un cavallo mafioso o di una donna mafiosa, come aggettivo di qualità estetica o morale...
L. La definizione di Pitrè è stata riproposta come parola definitiva della «scienza», innumerevoli
volte, nelle aule dei tribunali e nelle riviste giuridiche. Per cento e più anni, ha formato il fulcro delle
fumose pseudospiegazioni fornite dai siciliani ai continentali sull’essenza nascosta della mafia.
Logico che se ne siano serviti i mafiosi stessi.
S. Ironicamente, ne riprenderà i termini Leonardo Sciascia in un racconto del 1960 intitolato «Filologia», nel
quale un mafioso viene istruito da un uomo di cultura siciliano prima di un’audizione davanti alla Commissione
parlamentare antimafia, per portare «un contributo alla confusione, si capisce... e te lo garantisco io che a un certo
punto non si capirà più niente: tra storia, filologia e lettere anonime non si capirà più niente, niente...».
L. Chissà quante volte sarà successo, direttamente o indirettamente. D’altronde Pitrè usa la stessa
tecnica mistificatoria per la parola omertà, che per lui sta per omineità, cioè virilità: il siciliano
avrebbe un senso poderoso della propria virilità, sarebbe insomma un maschio al cubo, che non
tollera le offese e quindi qualche volta può esagerare nella reazione. La parola, invece, viene da
umiltà, termine di derivazione massonica, che vuole indicare la regola dell’obbedienza all’interno di
un’organizzazione segreta – proprio quanto si voleva occultare.
S. Proprio negli stessi anni in cui Pitrè mette a punto la sua definizione di omertà e di mafia, lo stereotipo del
siciliano focoso e mal disposto a subire le prepotenze si fa strada in tutta Europa sulle note della «Cavalleria
rusticana» di Pietro Mascagni, ispirata alla novella di Giovanni Verga. Il cerchio dunque si chiude.
L. Verga però parlava di una situazione diversa, quella della Sicilia orientale, e comunque di una
cultura «di tutti», nella quale Pitrè tentava di occultare lo specifico mafioso. Ma la mafia e la società
siciliana di fine Ottocento non erano la stessa cosa.
S. È una distinzione sottile e difficile. Sempre restando a Verga, infatti, perché non considerare Mastro don
Gesualdo il classico archetipo del mafioso?
L. Mastro don Gesualdo rappresenta il prototipo del gabelloto che vorrebbe entrare a pieno titolo
nella classe dirigente paesana e non ci riesce. Però la storia non è ambientata a Riesi, a Favara o a
Corleone, ma a Vizzini, nella Sicilia orientale. Condizioni sociali simili non producono lo stesso
risultato, a conferma che siamo di fronte a fenomeni specifici. Forse molti mafiosi di quel tempo
erano simili a Mastro don Gesualdo, ma non credo che, creando il suo personaggio, Verga pensasse
33