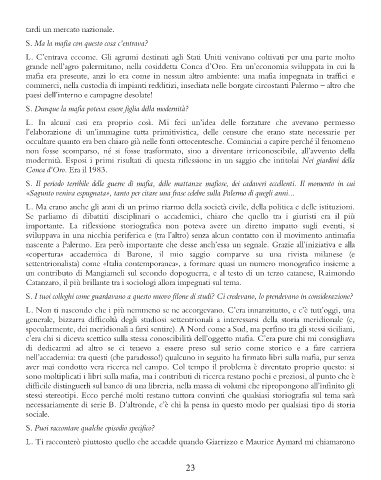Page 23 - Potere criminale
P. 23
tardi un mercato nazionale.
S. Ma la mafia con questo cosa c’entrava?
L. C’entrava eccome. Gli agrumi destinati agli Stati Uniti venivano coltivati per una parte molto
grande nell’agro palermitano, nella cosiddetta Conca d’Oro. Era un’economia sviluppata in cui la
mafia era presente, anzi lo era come in nessun altro ambiente: una mafia impegnata in traffici e
commerci, nella custodia di impianti redditizi, insediata nelle borgate circostanti Palermo – altro che
paesi dell’interno e campagne desolate!
S. Dunque la mafia poteva essere figlia della modernità?
L. In alcuni casi era proprio così. Mi feci un’idea delle forzature che avevano permesso
l’elaborazione di un’immagine tutta primitivistica, delle censure che erano state necessarie per
occultare quanto era ben chiaro già nelle fonti ottocentesche. Cominciai a capire perché il fenomeno
non fosse scomparso, né si fosse trasformato, sino a diventare irriconoscibile, all’avvento della
modernità. Esposi i primi risultati di questa riflessione in un saggio che intitolai Nei giardini della
Conca d’Oro. Era il 1983.
S. Il periodo terribile delle guerre di mafia, delle mattanze mafiose, dei cadaveri eccellenti. Il momento in cui
«Sagunto veniva espugnata», tanto per citare una frase celebre sulla Palermo di quegli anni...
L. Ma erano anche gli anni di un primo riarmo della società civile, della politica e delle istituzioni.
Se parliamo di dibattiti disciplinari o accademici, chiaro che quello tra i giuristi era il più
importante. La riflessione storiografica non poteva avere un diretto impatto sugli eventi, si
sviluppava in una nicchia periferica e (tra l’altro) senza alcun contatto con il movimento antimafia
nascente a Palermo. Era però importante che desse anch’essa un segnale. Grazie all’iniziativa e alla
«copertura» accademica di Barone, il mio saggio comparve su una rivista milanese (e
settentrionalista) come «Italia contemporanea», a formare quasi un numero monografico insieme a
un contributo di Mangiameli sul secondo dopoguerra, e al testo di un terzo catanese, Raimondo
Catanzaro, il più brillante tra i sociologi allora impegnati sul tema.
S. I tuoi colleghi come guardavano a questo nuovo filone di studi? Ci credevano, lo prendevano in considerazione?
L. Non ti nascondo che i più nemmeno se ne accorgevano. C’era innanzitutto, e c’è tutt’oggi, una
generale, bizzarra difficoltà degli studiosi settentrionali a interessarsi della storia meridionale (e,
specularmente, dei meridionali a farsi sentire). A Nord come a Sud, ma perfino tra gli stessi siciliani,
c’era chi si diceva scettico sulla stessa conoscibilità dell’oggetto mafia. C’era pure chi mi consigliava
di dedicarmi ad altro se ci tenevo a essere preso sul serio come storico e a fare carriera
nell’accademia: tra questi (che paradosso!) qualcuno in seguito ha firmato libri sulla mafia, pur senza
aver mai condotto vera ricerca nel campo. Col tempo il problema è diventato proprio questo: si
sono moltiplicati i libri sulla mafia, ma i contributi di ricerca restano pochi e preziosi, al punto che è
difficile distinguerli sul banco di una libreria, nella massa di volumi che ripropongono all’infinito gli
stessi stereotipi. Ecco perché molti restano tuttora convinti che qualsiasi storiografia sul tema sarà
necessariamente di serie B. D’altronde, c’è chi la pensa in questo modo per qualsiasi tipo di storia
sociale.
S. Puoi raccontare qualche episodio specifico?
L. Ti racconterò piuttosto quello che accadde quando Giarrizzo e Maurice Aymard mi chiamarono
23