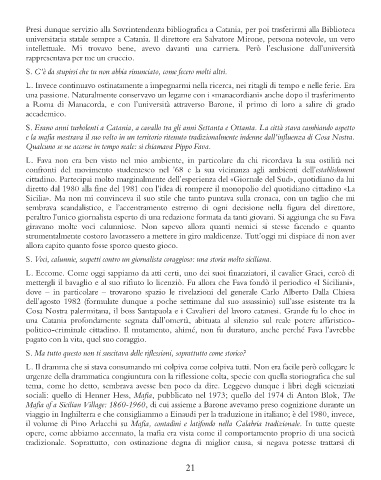Page 21 - Potere criminale
P. 21
Presi dunque servizio alla Sovrintendenza bibliografica a Catania, per poi trasferirmi alla Biblioteca
universitaria statale sempre a Catania. Il direttore era Salvatore Mirone, persona notevole, un vero
intellettuale. Mi trovavo bene, avevo davanti una carriera. Però l’esclusione dall’università
rappresentava per me un cruccio.
S. C’è da stupirsi che tu non abbia rinunciato, come fecero molti altri.
L. Invece continuavo ostinatamente a impegnarmi nella ricerca, nei ritagli di tempo e nelle ferie. Era
una passione. Naturalmente conservavo un legame con i «manacordiani» anche dopo il trasferimento
a Roma di Manacorda, e con l’università attraverso Barone, il primo di loro a salire di grado
accademico.
S. Erano anni turbolenti a Catania, a cavallo tra gli anni Settanta e Ottanta. La città stava cambiando aspetto
e la mafia mostrava il suo volto in un territorio ritenuto tradizionalmente indenne dall’influenza di Cosa Nostra.
Qualcuno se ne accorse in tempo reale: si chiamava Pippo Fava.
L. Fava non era ben visto nel mio ambiente, in particolare da chi ricordava la sua ostilità nei
confronti del movimento studentesco nel ’68 e la sua vicinanza agli ambienti dell’establishment
cittadino. Partecipai molto marginalmente dell’esperienza del «Giornale del Sud», quotidiano da lui
diretto dal 1980 alla fine del 1981 con l’idea di rompere il monopolio del quotidiano cittadino «La
Sicilia». Ma non mi convinceva il suo stile che tanto puntava sulla cronaca, con un taglio che mi
sembrava scandalistico, e l’accentramento estremo di ogni decisione nella figura del direttore,
peraltro l’unico giornalista esperto di una redazione formata da tanti giovani. Si aggiunga che su Fava
giravano molte voci calunniose. Non sapevo allora quanti nemici si stesse facendo e quanto
strumentalmente costoro lavorassero a mettere in giro maldicenze. Tutt’oggi mi dispiace di non aver
allora capito quanto fosse sporco questo gioco.
S. Voci, calunnie, sospetti contro un giornalista coraggioso: una storia molto siciliana.
L. Eccome. Come oggi sappiamo da atti certi, uno dei suoi finanziatori, il cavalier Graci, cercò di
mettergli il bavaglio e al suo rifiuto lo licenziò. Fu allora che Fava fondò il periodico «I Siciliani»,
dove – in particolare – trovarono spazio le rivelazioni del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa
dell’agosto 1982 (formulate dunque a poche settimane dal suo assassinio) sull’asse esistente tra la
Cosa Nostra palermitana, il boss Santapaola e i Cavalieri del lavoro catanesi. Grande fu lo choc in
una Catania profondamente segnata dall’omertà, abituata al silenzio sul reale potere affaristico-
politico-criminale cittadino. Il mutamento, ahimé, non fu duraturo, anche perché Fava l’avrebbe
pagato con la vita, quel suo coraggio.
S. Ma tutto questo non ti suscitava delle riflessioni, soprattutto come storico?
L. Il dramma che si stava consumando mi colpiva come colpiva tutti. Non era facile però collegare le
urgenze della drammatica congiuntura con la riflessione colta, specie con quella storiografica che sul
tema, come ho detto, sembrava avesse ben poco da dire. Leggevo dunque i libri degli scienziati
sociali: quello di Henner Hess, Mafia, pubblicato nel 1973; quello del 1974 di Anton Blok, The
Mafia of a Sicilian Village: 1860-1960, di cui assieme a Barone avevamo preso cognizione durante un
viaggio in Inghilterra e che consigliammo a Einaudi per la traduzione in italiano; è del 1980, invece,
il volume di Pino Arlacchi su Mafia, contadini e latifondo nella Calabria tradizionale. In tutte queste
opere, come abbiamo accennato, la mafia era vista come il comportamento proprio di una società
tradizionale. Soprattutto, con ostinazione degna di miglior causa, si negava potesse trattarsi di
21