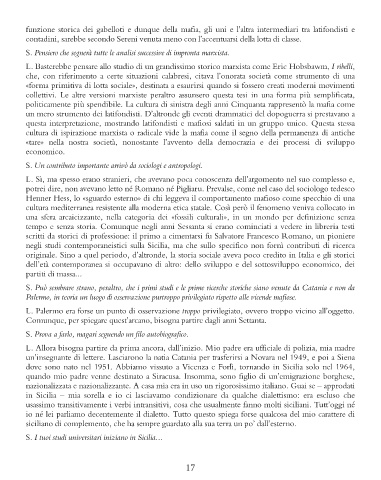Page 17 - Potere criminale
P. 17
funzione storica dei gabelloti e dunque della mafia, gli uni e l’altra intermediari tra latifondisti e
contadini, sarebbe secondo Sereni venuta meno con l’accentuarsi della lotta di classe.
S. Pensiero che segnerà tutte le analisi successive di impronta marxista.
L. Basterebbe pensare allo studio di un grandissimo storico marxista come Eric Hobsbawm, I ribelli,
che, con riferimento a certe situazioni calabresi, citava l’onorata società come strumento di una
«forma primitiva di lotta sociale», destinata a esaurirsi quando si fossero creati moderni movimenti
collettivi. Le altre versioni marxiste peraltro assunsero questa tesi in una forma più semplificata,
politicamente più spendibile. La cultura di sinistra degli anni Cinquanta rappresentò la mafia come
un mero strumento dei latifondisti. D’altronde gli eventi drammatici del dopoguerra si prestavano a
questa interpretazione, mostrando latifondisti e mafiosi saldati in un gruppo unico. Questa stessa
cultura di ispirazione marxista o radicale vide la mafia come il segno della permanenza di antiche
«tare» nella nostra società, nonostante l’avvento della democrazia e dei processi di sviluppo
economico.
S. Un contributo importante arrivò da sociologi e antropologi.
L. Sì, ma spesso erano stranieri, che avevano poca conoscenza dell’argomento nel suo complesso e,
potrei dire, non avevano letto né Romano né Pigliaru. Prevalse, come nel caso del sociologo tedesco
Henner Hess, lo «sguardo esterno» di chi leggeva il comportamento mafioso come specchio di una
cultura mediterranea resistente alla moderna etica statale. Così però il fenomeno veniva collocato in
una sfera arcaicizzante, nella categoria dei «fossili culturali», in un mondo per definizione senza
tempo e senza storia. Comunque negli anni Sessanta si erano cominciati a vedere in libreria testi
scritti da storici di professione: il primo a cimentarsi fu Salvatore Francesco Romano, un pioniere
negli studi contemporaneistici sulla Sicilia, ma che sullo specifico non fornì contributi di ricerca
originale. Sino a quel periodo, d’altronde, la storia sociale aveva poco credito in Italia e gli storici
dell’età contemporanea si occupavano di altro: dello sviluppo e del sottosviluppo economico, dei
partiti di massa...
S. Può sembrare strano, peraltro, che i primi studi e le prime ricerche storiche siano venute da Catania e non da
Palermo, in teoria un luogo di osservazione purtroppo privilegiato rispetto alle vicende mafiose.
L. Palermo era forse un punto di osservazione troppo privilegiato, ovvero troppo vicino all’oggetto.
Comunque, per spiegare quest’arcano, bisogna partire dagli anni Settanta.
S. Prova a farlo, magari seguendo un filo autobiografico.
L. Allora bisogna partire da prima ancora, dall’inizio. Mio padre era ufficiale di polizia, mia madre
un’insegnante di lettere. Lasciarono la natia Catania per trasferirsi a Novara nel 1949, e poi a Siena
dove sono nato nel 1951. Abbiamo vissuto a Vicenza e Forlì, tornando in Sicilia solo nel 1964,
quando mio padre venne destinato a Siracusa. Insomma, sono figlio di un’emigrazione borghese,
nazionalizzata e nazionalizzante. A casa mia era in uso un rigorosissimo italiano. Guai se – approdati
in Sicilia – mia sorella e io ci lasciavamo condizionare da qualche dialettismo: era escluso che
usassimo transitivamente i verbi intransitivi, cosa che usualmente fanno molti siciliani. Tutt’oggi né
io né lei parliamo decentemente il dialetto. Tutto questo spiega forse qualcosa del mio carattere di
siciliano di complemento, che ha sempre guardato alla sua terra un po’ dall’esterno.
S. I tuoi studi universitari iniziano in Sicilia...
17