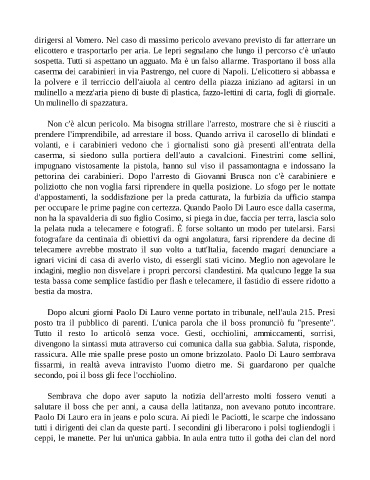Page 110 - Gomorra
P. 110
dirigersi al Vomero. Nel caso di massimo pericolo avevano previsto di far atterrare un
elicottero e trasportarlo per aria. Le lepri segnalano che lungo il percorso c'è un'auto
sospetta. Tutti si aspettano un agguato. Ma è un falso allarme. Trasportano il boss alla
caserma dei carabinieri in via Pastrengo, nel cuore di Napoli. L'elicottero si abbassa e
la polvere e il terriccio dell'aiuola al centro della piazza iniziano ad agitarsi in un
mulinello a mezz'aria pieno di buste di plastica, fazzo-lettini di carta, fogli di giornale.
Un mulinello di spazzatura.
Non c'è alcun pericolo. Ma bisogna strillare l'arresto, mostrare che si è riusciti a
prendere l'imprendibile, ad arrestare il boss. Quando arriva il carosello di blindati e
volanti, e i carabinieri vedono che i giornalisti sono già presenti all'entrata della
caserma, si siedono sulla portiera dell'auto a cavalcioni. Finestrini come sellini,
impugnano vistosamente la pistola, hanno sul viso il passamontagna e indossano la
pettorina dei carabinieri. Dopo l'arresto di Giovanni Brusca non c'è carabiniere e
poliziotto che non voglia farsi riprendere in quella posizione. Lo sfogo per le nottate
d'appostamenti, la soddisfazione per la preda catturata, la furbizia da ufficio stampa
per occupare le prime pagine con certezza. Quando Paolo Di Lauro esce dalla caserma,
non ha la spavalderia di suo figlio Cosimo, si piega in due, faccia per terra, lascia solo
la pelata nuda a telecamere e fotografi. È forse soltanto un modo per tutelarsi. Farsi
fotografare da centinaia di obiettivi da ogni angolatura, farsi riprendere da decine di
telecamere avrebbe mostrato il suo volto a tutt'Italia, facendo magari denunciare a
ignari vicini di casa di averlo visto, di essergli stati vicino. Meglio non agevolare le
indagini, meglio non disvelare i propri percorsi clandestini. Ma qualcuno legge la sua
testa bassa come semplice fastidio per flash e telecamere, il fastidio di essere ridotto a
bestia da mostra.
Dopo alcuni giorni Paolo Di Lauro venne portato in tribunale, nell'aula 215. Presi
posto tra il pubblico di parenti. L'unica parola che il boss pronunciò fu "presente".
Tutto il resto lo articolò senza voce. Gesti, occhiolini, ammiccamenti, sorrisi,
divengono la sintassi muta attraverso cui comunica dalla sua gabbia. Saluta, risponde,
rassicura. Alle mie spalle prese posto un omone brizzolato. Paolo Di Lauro sembrava
fissarmi, in realtà aveva intravisto l'uomo dietro me. Si guardarono per qualche
secondo, poi il boss gli fece l'occhiolino.
Sembrava che dopo aver saputo la notizia dell'arresto molti fossero venuti a
salutare il boss che per anni, a causa della latitanza, non avevano potuto incontrare.
Paolo Di Lauro era in jeans e polo scura. Ai piedi le Paciotti, le scarpe che indossano
tutti i dirigenti dei clan da queste parti. I secondini gli liberarono i polsi togliendogli i
ceppi, le manette. Per lui un'unica gabbia. In aula entra tutto il gotha dei clan del nord