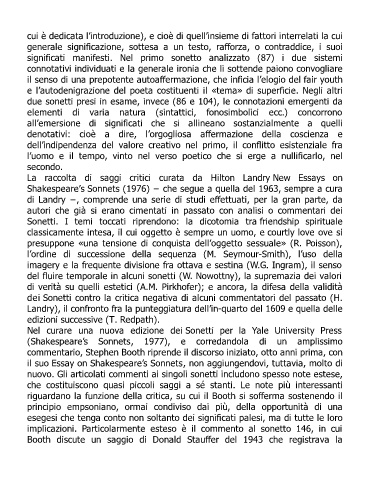Page 1783 - Shakespeare - Vol. 4
P. 1783
cui è dedicata l’introduzione), e cioè di quell’insieme di fattori interrelati la cui
generale significazione, sottesa a un testo, rafforza, o contraddice, i suoi
significati manifesti. Nel primo sonetto analizzato (87) i due sistemi
connotativi individuati e la generale ironia che li sottende paiono convogliare
il senso di una prepotente autoaffermazione, che inficia l’elogio del fair youth
e l’autodenigrazione del poeta costituenti il «tema» di superficie. Negli altri
due sonetti presi in esame, invece (86 e 104), le connotazioni emergenti da
elementi di varia natura (sintattici, fonosimbolici ecc.) concorrono
all’emersione di significati che si allineano sostanzialmente a quelli
denotativi: cioè a dire, l’orgogliosa affermazione della coscienza e
dell’indipendenza del valore creativo nel primo, il conflitto esistenziale fra
l’uomo e il tempo, vinto nel verso poetico che si erge a nullificarlo, nel
secondo.
La raccolta di saggi critici curata da Hilton Landry New Essays on
Shakespeare’s Sonnets (1976) − che segue a quella del 1963, sempre a cura
di Landry −, comprende una serie di studi effettuati, per la gran parte, da
autori che già si erano cimentati in passato con analisi o commentari dei
Sonetti. I temi toccati riprendono: la dicotomia tra friendship spirituale
classicamente intesa, il cui oggetto è sempre un uomo, e courtly love ove si
presuppone «una tensione di conquista dell’oggetto sessuale» (R. Poisson),
l’ordine di successione della sequenza (M. Seymour-Smith), l’uso della
imagery e la frequente divisione fra ottava e sestina (W.G. Ingram), il senso
del fluire temporale in alcuni sonetti (W. Nowottny), la supremazia dei valori
di verità su quelli estetici (A.M. Pirkhofer); e ancora, la difesa della validità
dei Sonetti contro la critica negativa di alcuni commentatori del passato (H.
Landry), il confronto fra la punteggiatura dell’in-quarto del 1609 e quella delle
edizioni successive (T. Redpath).
Nel curare una nuova edizione dei Sonetti per la Yale University Press
(Shakespeare’s Sonnets, 1977), e corredandola di un amplissimo
commentario, Stephen Booth riprende il discorso iniziato, otto anni prima, con
il suo Essay on Shakespeare’s Sonnets, non aggiungendovi, tuttavia, molto di
nuovo. Gli articolati commenti ai singoli sonetti includono spesso note estese,
che costituiscono quasi piccoli saggi a sé stanti. Le note più interessanti
riguardano la funzione della critica, su cui il Booth si sofferma sostenendo il
principio empsoniano, ormai condiviso dai più, della opportunità di una
esegesi che tenga conto non soltanto dei significati palesi, ma di tutte le loro
implicazioni. Particolarmente esteso è il commento al sonetto 146, in cui
Booth discute un saggio di Donald Stauffer del 1943 che registrava la