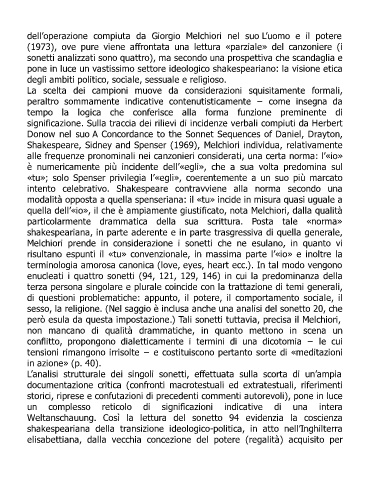Page 1778 - Shakespeare - Vol. 4
P. 1778
dell’operazione compiuta da Giorgio Melchiori nel suo L’uomo e il potere
(1973), ove pure viene affrontata una lettura «parziale» del canzoniere (i
sonetti analizzati sono quattro), ma secondo una prospettiva che scandaglia e
pone in luce un vastissimo settore ideologico shakespeariano: la visione etica
degli ambiti politico, sociale, sessuale e religioso.
La scelta dei campioni muove da considerazioni squisitamente formali,
peraltro sommamente indicative contenutisticamente − come insegna da
tempo la logica che conferisce alla forma funzione preminente di
significazione. Sulla traccia dei rilievi di incidenze verbali compiuti da Herbert
Donow nel suo A Concordance to the Sonnet Sequences of Daniel, Drayton,
Shakespeare, Sidney and Spenser (1969), Melchiori individua, relativamente
alle frequenze pronominali nei canzonieri considerati, una certa norma: l’«io»
è numericamente più incidente dell’«egli», che a sua volta predomina sul
«tu»; solo Spenser privilegia l’«egli», coerentemente a un suo più marcato
intento celebrativo. Shakespeare contravviene alla norma secondo una
modalità opposta a quella spenseriana: il «tu» incide in misura quasi uguale a
quella dell’«io», il che è ampiamente giustificato, nota Melchiori, dalla qualità
particolarmente drammatica della sua scrittura. Posta tale «norma»
shakespeariana, in parte aderente e in parte trasgressiva di quella generale,
Melchiori prende in considerazione i sonetti che ne esulano, in quanto vi
risultano espunti il «tu» convenzionale, in massima parte l’«io» e inoltre la
terminologia amorosa canonica (love, eyes, heart ecc.). In tal modo vengono
enucleati i quattro sonetti (94, 121, 129, 146) in cui la predominanza della
terza persona singolare e plurale coincide con la trattazione di temi generali,
di questioni problematiche: appunto, il potere, il comportamento sociale, il
sesso, la religione. (Nel saggio è inclusa anche una analisi del sonetto 20, che
però esula da questa impostazione.) Tali sonetti tuttavia, precisa il Melchiori,
non mancano di qualità drammatiche, in quanto mettono in scena un
conflitto, propongono dialetticamente i termini di una dicotomia − le cui
tensioni rimangono irrisolte − e costituiscono pertanto sorte di «meditazioni
in azione» (p. 40).
L’analisi strutturale dei singoli sonetti, effettuata sulla scorta di un’ampia
documentazione critica (confronti macrotestuali ed extratestuali, riferimenti
storici, riprese e confutazioni di precedenti commenti autorevoli), pone in luce
un complesso reticolo di significazioni indicative di una intera
Weltanschauung. Così la lettura del sonetto 94 evidenzia la coscienza
shakespeariana della transizione ideologico-politica, in atto nell’Inghilterra
elisabettiana, dalla vecchia concezione del potere (regalità) acquisito per