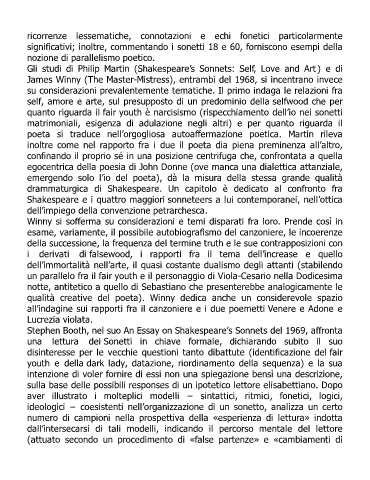Page 1775 - Shakespeare - Vol. 4
P. 1775
ricorrenze lessematiche, connotazioni e echi fonetici particolarmente
significativi; inoltre, commentando i sonetti 18 e 60, forniscono esempi della
nozione di parallelismo poetico.
Gli studi di Philip Martin (Shakespeare’s Sonnets: Self, Love and Art ) e di
James Winny (The Master-Mistress), entrambi del 1968, si incentrano invece
su considerazioni prevalentemente tematiche. Il primo indaga le relazioni fra
self, amore e arte, sul presupposto di un predominio della selfwood che per
quanto riguarda il fair youth è narcisismo (rispecchiamento dell’io nei sonetti
matrimoniali, esigenza di adulazione negli altri) e per quanto riguarda il
poeta si traduce nell’orgogliosa autoaffermazione poetica. Martin rileva
inoltre come nel rapporto fra i due il poeta dia piena preminenza all’altro,
confinando il proprio sé in una posizione centrifuga che, confrontata a quella
egocentrica della poesia di John Donne (ove manca una dialettica attanziale,
emergendo solo l’io del poeta), dà la misura della stessa grande qualità
drammaturgica di Shakespeare. Un capitolo è dedicato al confronto fra
Shakespeare e i quattro maggiori sonneteers a lui contemporanei, nell’ottica
dell’impiego della convenzione petrarchesca.
Winny si sofferma su considerazioni e temi disparati fra loro. Prende così in
esame, variamente, il possibile autobiografismo del canzoniere, le incoerenze
della successione, la frequenza del termine truth e le sue contrapposizioni con
i derivati di falsewood, i rapporti fra il tema dell’increase e quello
dell’immortalità nell’arte, il quasi costante dualismo degli attanti (stabilendo
un parallelo fra il fair youth e il personaggio di Viola-Cesario nella Dodicesima
notte, antitetico a quello di Sebastiano che presenterebbe analogicamente le
qualità creative del poeta). Winny dedica anche un considerevole spazio
all’indagine sui rapporti fra il canzoniere e i due poemetti Venere e Adone e
Lucrezia violata.
Stephen Booth, nel suo An Essay on Shakespeare’s Sonnets del 1969, affronta
una lettura dei Sonetti in chiave formale, dichiarando subito il suo
disinteresse per le vecchie questioni tanto dibattute (identificazione del fair
youth e della dark lady, datazione, riordinamento della sequenza) e la sua
intenzione di voler fornire di essi non una spiegazione bensì una descrizione,
sulla base delle possibili responses di un ipotetico lettore elisabettiano. Dopo
aver illustrato i molteplici modelli − sintattici, ritmici, fonetici, logici,
ideologici − coesistenti nell’organizzazione di un sonetto, analizza un certo
numero di campioni nella prospettiva della «esperienza di lettura» indotta
dall’intersecarsi di tali modelli, indicando il percorso mentale del lettore
(attuato secondo un procedimento di «false partenze» e «cambiamenti di