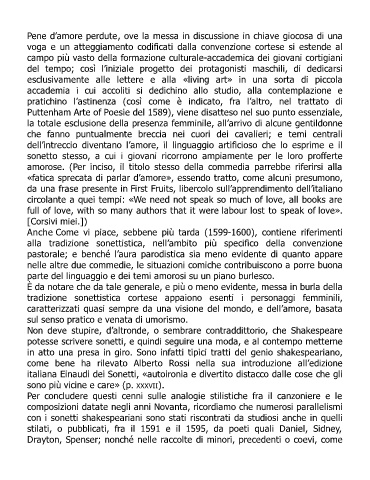Page 1772 - Shakespeare - Vol. 4
P. 1772
Pene d’amore perdute, ove la messa in discussione in chiave giocosa di una
voga e un atteggiamento codificati dalla convenzione cortese si estende al
campo più vasto della formazione culturale-accademica dei giovani cortigiani
del tempo; così l’iniziale progetto dei protagonisti maschili, di dedicarsi
esclusivamente alle lettere e alla «living art» in una sorta di piccola
accademia i cui accoliti si dedichino allo studio, alla contemplazione e
pratichino l’astinenza (così come è indicato, fra l’altro, nel trattato di
Puttenham Arte of Poesie del 1589), viene disatteso nel suo punto essenziale,
la totale esclusione della presenza femminile, all’arrivo di alcune gentildonne
che fanno puntualmente breccia nei cuori dei cavalieri; e temi centrali
dell’intreccio diventano l’amore, il linguaggio artificioso che lo esprime e il
sonetto stesso, a cui i giovani ricorrono ampiamente per le loro profferte
amorose. (Per inciso, il titolo stesso della commedia parrebbe riferirsi alla
«fatica sprecata di parlar d’amore», essendo tratto, come alcuni presumono,
da una frase presente in First Fruits, libercolo sull’apprendimento dell’italiano
circolante a quei tempi: «We need not speak so much of love, all books are
full of love, with so many authors that it were labour lost to speak of love».
[Corsivi miei.])
Anche Come vi piace, sebbene più tarda (1599-1600), contiene riferimenti
alla tradizione sonettistica, nell’ambito più specifico della convenzione
pastorale; e benché l’aura parodistica sia meno evidente di quanto appare
nelle altre due commedie, le situazioni comiche contribuiscono a porre buona
parte del linguaggio e dei temi amorosi su un piano burlesco.
È da notare che da tale generale, e più o meno evidente, messa in burla della
tradizione sonettistica cortese appaiono esenti i personaggi femminili,
caratterizzati quasi sempre da una visione del mondo, e dell’amore, basata
sul senso pratico e venata di umorismo.
Non deve stupire, d’altronde, o sembrare contraddittorio, che Shakespeare
potesse scrivere sonetti, e quindi seguire una moda, e al contempo metterne
in atto una presa in giro. Sono infatti tipici tratti del genio shakespeariano,
come bene ha rilevato Alberto Rossi nella sua introduzione all’edizione
italiana Einaudi dei Sonetti, «autoironia e divertito distacco dalle cose che gli
sono più vicine e care» (p. XXXVII).
Per concludere questi cenni sulle analogie stilistiche fra il canzoniere e le
composizioni datate negli anni Novanta, ricordiamo che numerosi parallelismi
con i sonetti shakespeariani sono stati riscontrati da studiosi anche in quelli
stilati, o pubblicati, fra il 1591 e il 1595, da poeti quali Daniel, Sidney,
Drayton, Spenser; nonché nelle raccolte di minori, precedenti o coevi, come