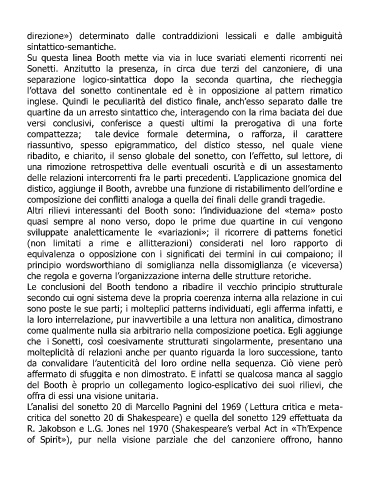Page 1776 - Shakespeare - Vol. 4
P. 1776
direzione») determinato dalle contraddizioni lessicali e dalle ambiguità
sintattico-semantiche.
Su questa linea Booth mette via via in luce svariati elementi ricorrenti nei
Sonetti. Anzitutto la presenza, in circa due terzi del canzoniere, di una
separazione logico-sintattica dopo la seconda quartina, che riecheggia
l’ottava del sonetto continentale ed è in opposizione al pattern rimatico
inglese. Quindi le peculiarità del distico finale, anch’esso separato dalle tre
quartine da un arresto sintattico che, interagendo con la rima baciata dei due
versi conclusivi, conferisce a questi ultimi la prerogativa di una forte
compattezza; tale device formale determina, o rafforza, il carattere
riassuntivo, spesso epigrammatico, del distico stesso, nel quale viene
ribadito, e chiarito, il senso globale del sonetto, con l’effetto, sul lettore, di
una rimozione retrospettiva delle eventuali oscurità e di un assestamento
delle relazioni intercorrenti fra le parti precedenti. L’applicazione gnomica del
distico, aggiunge il Booth, avrebbe una funzione di ristabilimento dell’ordine e
composizione dei conflitti analoga a quella dei finali delle grandi tragedie.
Altri rilievi interessanti del Booth sono: l’individuazione del «tema» posto
quasi sempre al nono verso, dopo le prime due quartine in cui vengono
sviluppate analetticamente le «variazioni»; il ricorrere di patterns fonetici
(non limitati a rime e allitterazioni) considerati nel loro rapporto di
equivalenza o opposizione con i significati dei termini in cui compaiono; il
principio wordsworthiano di somiglianza nella dissomiglianza (e viceversa)
che regola e governa l’organizzazione interna delle strutture retoriche.
Le conclusioni del Booth tendono a ribadire il vecchio principio strutturale
secondo cui ogni sistema deve la propria coerenza interna alla relazione in cui
sono poste le sue parti; i molteplici patterns individuati, egli afferma infatti, e
la loro interrelazione, pur inavvertibile a una lettura non analitica, dimostrano
come qualmente nulla sia arbitrario nella composizione poetica. Egli aggiunge
che i Sonetti, così coesivamente strutturati singolarmente, presentano una
molteplicità di relazioni anche per quanto riguarda la loro successione, tanto
da convalidare l’autenticità del loro ordine nella sequenza. Ciò viene però
affermato di sfuggita e non dimostrato. E infatti se qualcosa manca al saggio
del Booth è proprio un collegamento logico-esplicativo dei suoi rilievi, che
offra di essi una visione unitaria.
L’analisi del sonetto 20 di Marcello Pagnini del 1969 ( Lettura critica e meta-
critica del sonetto 20 di Shakespeare) e quella del sonetto 129 effettuata da
R. Jakobson e L.G. Jones nel 1970 (Shakespeare’s verbal Act in «Th’Expence
of Spirit»), pur nella visione parziale che del canzoniere offrono, hanno