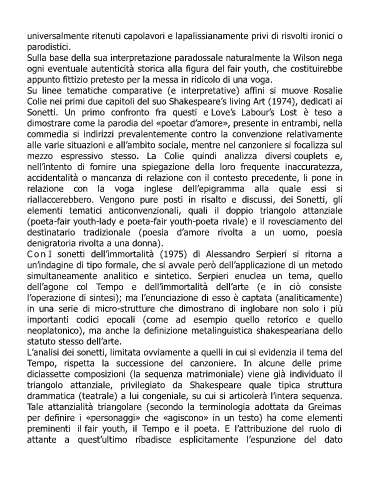Page 1781 - Shakespeare - Vol. 4
P. 1781
universalmente ritenuti capolavori e lapalissianamente privi di risvolti ironici o
parodistici.
Sulla base della sua interpretazione paradossale naturalmente la Wilson nega
ogni eventuale autenticità storica alla figura del fair youth, che costituirebbe
appunto fittizio pretesto per la messa in ridicolo di una voga.
Su linee tematiche comparative (e interpretative) affini si muove Rosalie
Colie nei primi due capitoli del suo Shakespeare’s living Art (1974), dedicati ai
Sonetti. Un primo confronto fra questi e Love’s Labour’s Lost è teso a
dimostrare come la parodia del «poetar d’amore», presente in entrambi, nella
commedia si indirizzi prevalentemente contro la convenzione relativamente
alle varie situazioni e all’ambito sociale, mentre nel canzoniere si focalizza sul
mezzo espressivo stesso. La Colie quindi analizza diversi couplets e,
nell’intento di fornire una spiegazione della loro frequente inaccuratezza,
accidentalità o mancanza di relazione con il contesto precedente, li pone in
relazione con la voga inglese dell’epigramma alla quale essi si
riallaccerebbero. Vengono pure posti in risalto e discussi, dei Sonetti, gli
elementi tematici anticonvenzionali, quali il doppio triangolo attanziale
(poeta-fair youth-lady e poeta-fair youth-poeta rivale) e il rovesciamento del
destinatario tradizionale (poesia d’amore rivolta a un uomo, poesia
denigratoria rivolta a una donna).
C o n I sonetti dell’immortalità (1975) di Alessandro Serpieri si ritorna a
un’indagine di tipo formale, che si avvale però dell’applicazione di un metodo
simultaneamente analitico e sintetico. Serpieri enuclea un tema, quello
dell’agone col Tempo e dell’immortalità dell’arte (e in ciò consiste
l’operazione di sintesi); ma l’enunciazione di esso è captata (analiticamente)
in una serie di micro-strutture che dimostrano di inglobare non solo i più
importanti codici epocali (come ad esempio quello retorico e quello
neoplatonico), ma anche la definizione metalinguistica shakespeariana dello
statuto stesso dell’arte.
L’analisi dei sonetti, limitata ovviamente a quelli in cui si evidenzia il tema del
Tempo, rispetta la successione del canzoniere. In alcune delle prime
diciassette composizioni (la sequenza matrimoniale) viene già individuato il
triangolo attanziale, privilegiato da Shakespeare quale tipica struttura
drammatica (teatrale) a lui congeniale, su cui si articolerà l’intera sequenza.
Tale attanzialità triangolare (secondo la terminologia adottata da Greimas
per definire i «personaggi» che «agiscono» in un testo) ha come elementi
preminenti il fair youth, il Tempo e il poeta. E l’attribuzione del ruolo di
attante a quest’ultimo ribadisce esplicitamente l’espunzione del dato