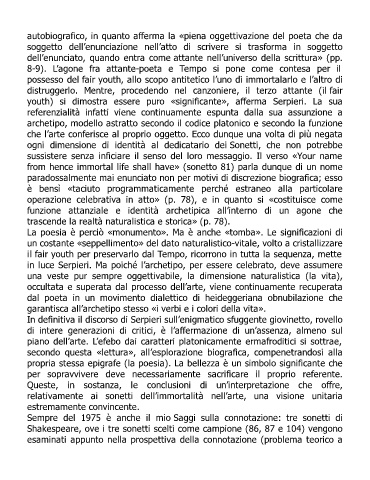Page 1782 - Shakespeare - Vol. 4
P. 1782
autobiografico, in quanto afferma la «piena oggettivazione del poeta che da
soggetto dell’enunciazione nell’atto di scrivere si trasforma in soggetto
dell’enunciato, quando entra come attante nell’universo della scrittura» (pp.
8-9). L’agone fra attante-poeta e Tempo si pone come contesa per il
possesso del fair youth, allo scopo antitetico l’uno di immortalarlo e l’altro di
distruggerlo. Mentre, procedendo nel canzoniere, il terzo attante (il fair
youth) si dimostra essere puro «significante», afferma Serpieri. La sua
referenzialità infatti viene continuamente espunta dalla sua assunzione a
archetipo, modello astratto secondo il codice platonico e secondo la funzione
che l’arte conferisce al proprio oggetto. Ecco dunque una volta di più negata
ogni dimensione di identità al dedicatario dei Sonetti, che non potrebbe
sussistere senza inficiare il senso del loro messaggio. Il verso «Your name
from hence immortal life shall have» (sonetto 81) parla dunque di un nome
paradossalmente mai enunciato non per motivi di discrezione biografica; esso
è bensì «taciuto programmaticamente perché estraneo alla particolare
operazione celebrativa in atto» (p. 78), e in quanto si «costituisce come
funzione attanziale e identità archetipica all’interno di un agone che
trascende la realtà naturalistica e storica» (p. 78).
La poesia è perciò «monumento». Ma è anche «tomba». Le significazioni di
un costante «seppellimento» del dato naturalistico-vitale, volto a cristallizzare
il fair youth per preservarlo dal Tempo, ricorrono in tutta la sequenza, mette
in luce Serpieri. Ma poiché l’archetipo, per essere celebrato, deve assumere
una veste pur sempre oggettivabile, la dimensione naturalistica (la vita),
occultata e superata dal processo dell’arte, viene continuamente recuperata
dal poeta in un movimento dialettico di heideggeriana obnubilazione che
garantisca all’archetipo stesso «i verbi e i colori della vita».
In definitiva il discorso di Serpieri sull’enigmatico sfuggente giovinetto, rovello
di intere generazioni di critici, è l’affermazione di un’assenza, almeno sul
piano dell’arte. L’efebo dai caratteri platonicamente ermafroditici si sottrae,
secondo questa «lettura», all’esplorazione biografica, compenetrandosi alla
propria stessa epigrafe (la poesia). La bellezza è un simbolo significante che
per sopravvivere deve necessariamente sacrificare il proprio referente.
Queste, in sostanza, le conclusioni di un’interpretazione che offre,
relativamente ai sonetti dell’immortalità nell’arte, una visione unitaria
estremamente convincente.
Sempre del 1975 è anche il mio Saggi sulla connotazione: tre sonetti di
Shakespeare, ove i tre sonetti scelti come campione (86, 87 e 104) vengono
esaminati appunto nella prospettiva della connotazione (problema teorico a