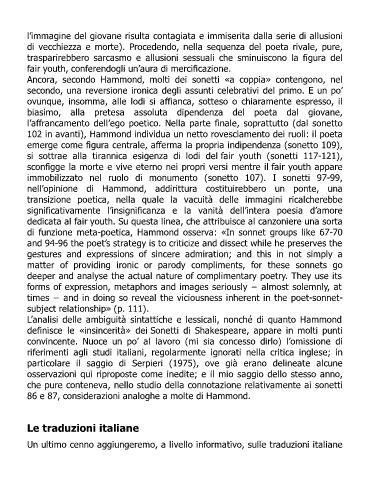Page 1785 - Shakespeare - Vol. 4
P. 1785
l’immagine del giovane risulta contagiata e immiserita dalla serie di allusioni
di vecchiezza e morte). Procedendo, nella sequenza del poeta rivale, pure,
trasparirebbero sarcasmo e allusioni sessuali che sminuiscono la figura del
fair youth, conferendogli un’aura di mercificazione.
Ancora, secondo Hammond, molti dei sonetti «a coppia» contengono, nel
secondo, una reversione ironica degli assunti celebrativi del primo. E un po’
ovunque, insomma, alle lodi si affianca, sotteso o chiaramente espresso, il
biasimo, alla pretesa assoluta dipendenza del poeta dal giovane,
l’affrancamento dell’ego poetico. Nella parte finale, soprattutto (dal sonetto
102 in avanti), Hammond individua un netto rovesciamento dei ruoli: il poeta
emerge come figura centrale, afferma la propria indipendenza (sonetto 109),
si sottrae alla tirannica esigenza di lodi del fair youth (sonetti 117-121),
sconfigge la morte e vive eterno nei propri versi mentre il fair youth appare
immobilizzato nel ruolo di monumento (sonetto 107). I sonetti 97-99,
nell’opinione di Hammond, addirittura costituirebbero un ponte, una
transizione poetica, nella quale la vacuità delle immagini ricalcherebbe
significativamente l’insignificanza e la vanità dell’intera poesia d’amore
dedicata al fair youth. Su questa linea, che attribuisce al canzoniere una sorta
di funzione meta-poetica, Hammond osserva: «In sonnet groups like 67-70
and 94-96 the poet’s strategy is to criticize and dissect while he preserves the
gestures and expressions of sincere admiration; and this in not simply a
matter of providing ironic or parody compliments, for these sonnets go
deeper and analyse the actual nature of complimentary poetry. They use its
forms of expression, metaphors and images seriously − almost solemnly, at
times − and in doing so reveal the viciousness inherent in the poet-sonnet-
subject relationship» (p. 111).
L’analisi delle ambiguità sintattiche e lessicali, nonché di quanto Hammond
definisce le «insincerità» dei Sonetti di Shakespeare, appare in molti punti
convincente. Nuoce un po’ al lavoro (mi sia concesso dirlo) l’omissione di
riferimenti agli studi italiani, regolarmente ignorati nella critica inglese; in
particolare il saggio di Serpieri (1975), ove già erano delineate alcune
osservazioni qui riproposte come inedite; e il mio saggio dello stesso anno,
che pure conteneva, nello studio della connotazione relativamente ai sonetti
86 e 87, considerazioni analoghe a molte di Hammond.
Le traduzioni italiane
Un ultimo cenno aggiungeremo, a livello informativo, sulle traduzioni italiane