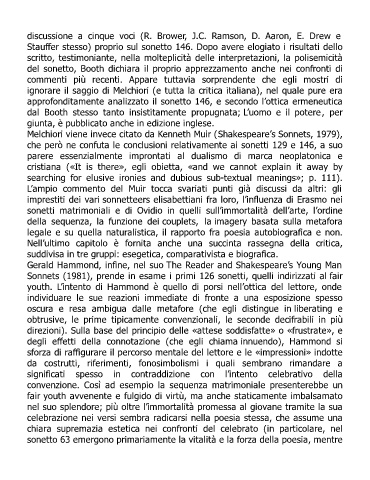Page 1784 - Shakespeare - Vol. 4
P. 1784
discussione a cinque voci (R. Brower, J.C. Ramson, D. Aaron, E. Drew e
Stauffer stesso) proprio sul sonetto 146. Dopo avere elogiato i risultati dello
scritto, testimoniante, nella molteplicità delle interpretazioni, la polisemicità
del sonetto, Booth dichiara il proprio apprezzamento anche nei confronti di
commenti più recenti. Appare tuttavia sorprendente che egli mostri di
ignorare il saggio di Melchiori (e tutta la critica italiana), nel quale pure era
approfonditamente analizzato il sonetto 146, e secondo l’ottica ermeneutica
dal Booth stesso tanto insistitamente propugnata; L’uomo e il potere, per
giunta, è pubblicato anche in edizione inglese.
Melchiori viene invece citato da Kenneth Muir (Shakespeare’s Sonnets, 1979),
che però ne confuta le conclusioni relativamente ai sonetti 129 e 146, a suo
parere essenzialmente improntati al dualismo di marca neoplatonica e
cristiana («It is there», egli obietta, «and we cannot explain it away by
searching for elusive ironies and dubious sub-textual meanings»; p. 111).
L’ampio commento del Muir tocca svariati punti già discussi da altri: gli
imprestiti dei vari sonnetteers elisabettiani fra loro, l’influenza di Erasmo nei
sonetti matrimoniali e di Ovidio in quelli sull’immortalità dell’arte, l’ordine
della sequenza, la funzione dei couplets, la imagery basata sulla metafora
legale e su quella naturalistica, il rapporto fra poesia autobiografica e non.
Nell’ultimo capitolo è fornita anche una succinta rassegna della critica,
suddivisa in tre gruppi: esegetica, comparativista e biografica.
Gerald Hammond, infine, nel suo The Reader and Shakespeare’s Young Man
Sonnets (1981), prende in esame i primi 126 sonetti, quelli indirizzati al fair
youth. L’intento di Hammond è quello di porsi nell’ottica del lettore, onde
individuare le sue reazioni immediate di fronte a una esposizione spesso
oscura e resa ambigua dalle metafore (che egli distingue in liberating e
obtrusive, le prime tipicamente convenzionali, le seconde decifrabili in più
direzioni). Sulla base del principio delle «attese soddisfatte» o «frustrate», e
degli effetti della connotazione (che egli chiama innuendo), Hammond si
sforza di raffigurare il percorso mentale del lettore e le «impressioni» indotte
da costrutti, riferimenti, fonosimbolismi i quali sembrano rimandare a
significati spesso in contraddizione con l’intento celebrativo della
convenzione. Così ad esempio la sequenza matrimoniale presenterebbe un
fair youth avvenente e fulgido di virtù, ma anche staticamente imbalsamato
nel suo splendore; più oltre l’immortalità promessa al giovane tramite la sua
celebrazione nei versi sembra radicarsi nella poesia stessa, che assume una
chiara supremazia estetica nei confronti del celebrato (in particolare, nel
sonetto 63 emergono primariamente la vitalità e la forza della poesia, mentre