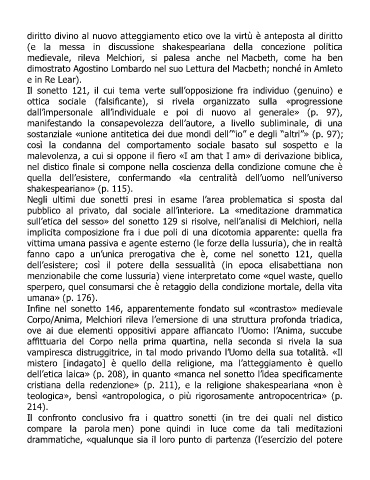Page 1779 - Shakespeare - Vol. 4
P. 1779
diritto divino al nuovo atteggiamento etico ove la virtù è anteposta al diritto
(e la messa in discussione shakespeariana della concezione politica
medievale, rileva Melchiori, si palesa anche nel Macbeth, come ha ben
dimostrato Agostino Lombardo nel suo Lettura del Macbeth; nonché in Amleto
e in Re Lear).
Il sonetto 121, il cui tema verte sull’opposizione fra individuo (genuino) e
ottica sociale (falsificante), si rivela organizzato sulla «progressione
dall’impersonale all’individuale e poi di nuovo al generale» (p. 97),
manifestando la consapevolezza dell’autore, a livello subliminale, di una
sostanziale «unione antitetica dei due mondi dell’“io” e degli “altri”» (p. 97);
così la condanna del comportamento sociale basato sul sospetto e la
malevolenza, a cui si oppone il fiero «I am that I am» di derivazione biblica,
nel distico finale si compone nella coscienza della condizione comune che è
quella dell’esistere, confermando «la centralità dell’uomo nell’universo
shakespeariano» (p. 115).
Negli ultimi due sonetti presi in esame l’area problematica si sposta dal
pubblico al privato, dal sociale all’interiore. La «meditazione drammatica
sull’etica del sesso» del sonetto 129 si risolve, nell’analisi di Melchiori, nella
implicita composizione fra i due poli di una dicotomia apparente: quella fra
vittima umana passiva e agente esterno (le forze della lussuria), che in realtà
fanno capo a un’unica prerogativa che è, come nel sonetto 121, quella
dell’esistere; così il potere della sessualità (in epoca elisabettiana non
menzionabile che come lussuria) viene interpretato come «quel waste, quello
sperpero, quel consumarsi che è retaggio della condizione mortale, della vita
umana» (p. 176).
Infine nel sonetto 146, apparentemente fondato sul «contrasto» medievale
Corpo/Anima, Melchiori rileva l’emersione di una struttura profonda triadica,
ove ai due elementi oppositivi appare affiancato l’Uomo: l’Anima, succube
affittuaria del Corpo nella prima quartina, nella seconda si rivela la sua
vampiresca distruggitrice, in tal modo privando l’Uomo della sua totalità. «Il
mistero [indagato] è quello della religione, ma l’atteggiamento è quello
dell’etica laica» (p. 208), in quanto «manca nel sonetto l’idea specificamente
cristiana della redenzione» (p. 211), e la religione shakespeariana «non è
teologica», bensì «antropologica, o più rigorosamente antropocentrica» (p.
214).
Il confronto conclusivo fra i quattro sonetti (in tre dei quali nel distico
compare la parola men) pone quindi in luce come da tali meditazioni
drammatiche, «qualunque sia il loro punto di partenza (l’esercizio del potere