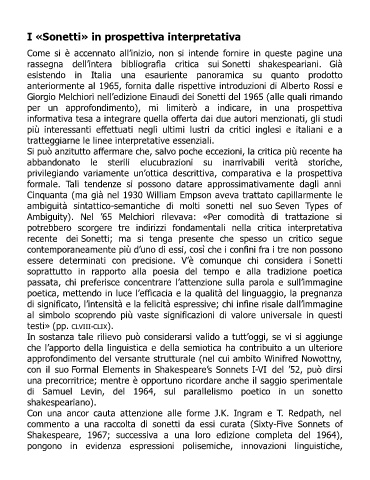Page 1774 - Shakespeare - Vol. 4
P. 1774
I «Sonetti» in prospettiva interpretativa
Come si è accennato all’inizio, non si intende fornire in queste pagine una
rassegna dell’intera bibliografia critica sui Sonetti shakespeariani. Già
esistendo in Italia una esauriente panoramica su quanto prodotto
anteriormente al 1965, fornita dalle rispettive introduzioni di Alberto Rossi e
Giorgio Melchiori nell’edizione Einaudi dei Sonetti del 1965 (alle quali rimando
per un approfondimento), mi limiterò a indicare, in una prospettiva
informativa tesa a integrare quella offerta dai due autori menzionati, gli studi
più interessanti effettuati negli ultimi lustri da critici inglesi e italiani e a
tratteggiarne le linee interpretative essenziali.
Si può anzitutto affermare che, salvo poche eccezioni, la critica più recente ha
abbandonato le sterili elucubrazioni su inarrivabili verità storiche,
privilegiando variamente un’ottica descrittiva, comparativa e la prospettiva
formale. Tali tendenze si possono datare approssimativamente dagli anni
Cinquanta (ma già nel 1930 William Empson aveva trattato capillarmente le
ambiguità sintattico-semantiche di molti sonetti nel suo Seven Types of
Ambiguity). Nel ’65 Melchiori rilevava: «Per comodità di trattazione si
potrebbero scorgere tre indirizzi fondamentali nella critica interpretativa
recente dei Sonetti; ma si tenga presente che spesso un critico segue
contemporaneamente più d’uno di essi, così che i confini fra i tre non possono
essere determinati con precisione. V’è comunque chi considera i Sonetti
soprattutto in rapporto alla poesia del tempo e alla tradizione poetica
passata, chi preferisce concentrare l’attenzione sulla parola e sull’immagine
poetica, mettendo in luce l’efficacia e la qualità del linguaggio, la pregnanza
di significato, l’intensità e la felicità espressive; chi infine risale dall’immagine
al simbolo scoprendo più vaste significazioni di valore universale in questi
testi» (pp. CLVIII-CLIX).
In sostanza tale rilievo può considerarsi valido a tutt’oggi, se vi si aggiunge
che l’apporto della linguistica e della semiotica ha contribuito a un ulteriore
approfondimento del versante strutturale (nel cui ambito Winifred Nowottny,
con il suo Formal Elements in Shakespeare’s Sonnets I-VI del ’52, può dirsi
una precorritrice; mentre è opportuno ricordare anche il saggio sperimentale
di Samuel Levin, del 1964, sul parallelismo poetico in un sonetto
shakespeariano).
Con una ancor cauta attenzione alle forme J.K. Ingram e T. Redpath, nel
commento a una raccolta di sonetti da essi curata (Sixty-Five Sonnets of
Shakespeare, 1967; successiva a una loro edizione completa del 1964),
pongono in evidenza espressioni polisemiche, innovazioni linguistiche,