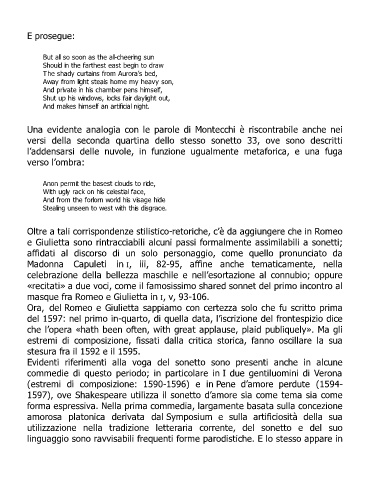Page 1771 - Shakespeare - Vol. 4
P. 1771
E prosegue:
But all so soon as the all-cheering sun
Should in the farthest east begin to draw
The shady curtains from Aurora’s bed,
Away from light steals home my heavy son,
And private in his chamber pens himself,
Shut up his windows, locks fair daylight out,
And makes himself an artificial night.
Una evidente analogia con le parole di Montecchi è riscontrabile anche nei
versi della seconda quartina dello stesso sonetto 33, ove sono descritti
l’addensarsi delle nuvole, in funzione ugualmente metaforica, e una fuga
verso l’ombra:
Anon permit the basest clouds to ride,
With ugly rack on his celestial face,
And from the forlorn world his visage hide
Stealing unseen to west with this disgrace.
Oltre a tali corrispondenze stilistico-retoriche, c’è da aggiungere che in Romeo
e Giulietta sono rintracciabili alcuni passi formalmente assimilabili a sonetti;
affidati al discorso di un solo personaggio, come quello pronunciato da
Madonna Capuleti in I, iii, 82-95, affine anche tematicamente, nella
celebrazione della bellezza maschile e nell’esortazione al connubio; oppure
«recitati» a due voci, come il famosissimo shared sonnet del primo incontro al
masque fra Romeo e Giulietta in I, v, 93-106.
Ora, del Romeo e Giulietta sappiamo con certezza solo che fu scritto prima
del 1597: nel primo in-quarto, di quella data, l’iscrizione del frontespizio dice
che l’opera «hath been often, with great applause, plaid publiquely». Ma gli
estremi di composizione, fissati dalla critica storica, fanno oscillare la sua
stesura fra il 1592 e il 1595.
Evidenti riferimenti alla voga del sonetto sono presenti anche in alcune
commedie di questo periodo; in particolare in I due gentiluomini di Verona
(estremi di composizione: 1590-1596) e in Pene d’amore perdute (1594-
1597), ove Shakespeare utilizza il sonetto d’amore sia come tema sia come
forma espressiva. Nella prima commedia, largamente basata sulla concezione
amorosa platonica derivata dal Symposium e sulla artificiosità della sua
utilizzazione nella tradizione letteraria corrente, del sonetto e del suo
linguaggio sono ravvisabili frequenti forme parodistiche. E lo stesso appare in