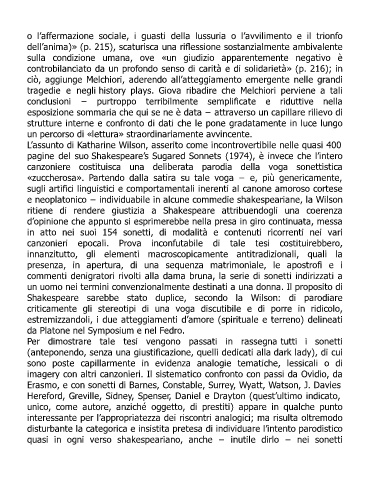Page 1780 - Shakespeare - Vol. 4
P. 1780
o l’affermazione sociale, i guasti della lussuria o l’avvilimento e il trionfo
dell’anima)» (p. 215), scaturisca una riflessione sostanzialmente ambivalente
sulla condizione umana, ove «un giudizio apparentemente negativo è
controbilanciato da un profondo senso di carità e di solidarietà» (p. 216); in
ciò, aggiunge Melchiori, aderendo all’atteggiamento emergente nelle grandi
tragedie e negli history plays. Giova ribadire che Melchiori perviene a tali
conclusioni − purtroppo terribilmente semplificate e riduttive nella
esposizione sommaria che qui se ne è data − attraverso un capillare rilievo di
strutture interne e confronto di dati che le pone gradatamente in luce lungo
un percorso di «lettura» straordinariamente avvincente.
L’assunto di Katharine Wilson, asserito come incontrovertibile nelle quasi 400
pagine del suo Shakespeare’s Sugared Sonnets (1974), è invece che l’intero
canzoniere costituisca una deliberata parodia della voga sonettistica
«zuccherosa». Partendo dalla satira su tale voga − e, più genericamente,
sugli artifici linguistici e comportamentali inerenti al canone amoroso cortese
e neoplatonico − individuabile in alcune commedie shakespeariane, la Wilson
ritiene di rendere giustizia a Shakespeare attribuendogli una coerenza
d’opinione che appunto si esprimerebbe nella presa in giro continuata, messa
in atto nei suoi 154 sonetti, di modalità e contenuti ricorrenti nei vari
canzonieri epocali. Prova inconfutabile di tale tesi costituirebbero,
innanzitutto, gli elementi macroscopicamente antitradizionali, quali la
presenza, in apertura, di una sequenza matrimoniale, le apostrofi e i
commenti denigratori rivolti alla dama bruna, la serie di sonetti indirizzati a
un uomo nei termini convenzionalmente destinati a una donna. Il proposito di
Shakespeare sarebbe stato duplice, secondo la Wilson: di parodiare
criticamente gli stereotipi di una voga discutibile e di porre in ridicolo,
estremizzandoli, i due atteggiamenti d’amore (spirituale e terreno) delineati
da Platone nel Symposium e nel Fedro.
Per dimostrare tale tesi vengono passati in rassegna tutti i sonetti
(anteponendo, senza una giustificazione, quelli dedicati alla dark lady), di cui
sono poste capillarmente in evidenza analogie tematiche, lessicali o di
imagery con altri canzonieri. Il sistematico confronto con passi da Ovidio, da
Erasmo, e con sonetti di Barnes, Constable, Surrey, Wyatt, Watson, J. Davies
Hereford, Greville, Sidney, Spenser, Daniel e Drayton (quest’ultimo indicato,
unico, come autore, anziché oggetto, di prestiti) appare in qualche punto
interessante per l’appropriatezza dei riscontri analogici; ma risulta oltremodo
disturbante la categorica e insistita pretesa di individuare l’intento parodistico
quasi in ogni verso shakespeariano, anche − inutile dirlo − nei sonetti