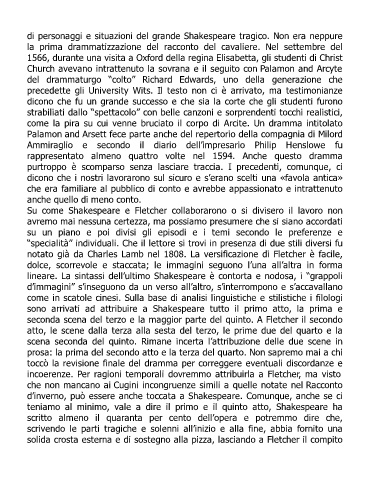Page 1135 - Shakespeare - Vol. 4
P. 1135
di personaggi e situazioni del grande Shakespeare tragico. Non era neppure
la prima drammatizzazione del racconto del cavaliere. Nel settembre del
1566, durante una visita a Oxford della regina Elisabetta, gli studenti di Christ
Church avevano intrattenuto la sovrana e il seguito con Palamon and Arcyte
del drammaturgo “colto” Richard Edwards, uno della generazione che
precedette gli University Wits. Il testo non ci è arrivato, ma testimonianze
dicono che fu un grande successo e che sia la corte che gli studenti furono
strabiliati dallo “spettacolo” con belle canzoni e sorprendenti tocchi realistici,
come la pira su cui venne bruciato il corpo di Arcite. Un dramma intitolato
Palamon and Arsett fece parte anche del repertorio della compagnia di Milord
Ammiraglio e secondo il diario dell’impresario Philip Henslowe fu
rappresentato almeno quattro volte nel 1594. Anche questo dramma
purtroppo è scomparso senza lasciare traccia. I precedenti, comunque, ci
dicono che i nostri lavorarono sul sicuro e s’erano scelti una «favola antica»
che era familiare al pubblico di conto e avrebbe appassionato e intrattenuto
anche quello di meno conto.
Su come Shakespeare e Fletcher collaborarono o si divisero il lavoro non
avremo mai nessuna certezza, ma possiamo presumere che si siano accordati
su un piano e poi divisi gli episodi e i temi secondo le preferenze e
“specialità” individuali. Che il lettore si trovi in presenza di due stili diversi fu
notato già da Charles Lamb nel 1808. La versificazione di Fletcher è facile,
dolce, scorrevole e staccata; le immagini seguono l’una all’altra in forma
lineare. La sintassi dell’ultimo Shakespeare è contorta e nodosa, i “grappoli
d’immagini” s’inseguono da un verso all’altro, s’interrompono e s’accavallano
come in scatole cinesi. Sulla base di analisi linguistiche e stilistiche i filologi
sono arrivati ad attribuire a Shakespeare tutto il primo atto, la prima e
seconda scena del terzo e la maggior parte del quinto. A Fletcher il secondo
atto, le scene dalla terza alla sesta del terzo, le prime due del quarto e la
scena seconda del quinto. Rimane incerta l’attribuzione delle due scene in
prosa: la prima del secondo atto e la terza del quarto. Non sapremo mai a chi
toccò la revisione finale del dramma per correggere eventuali discordanze e
incoerenze. Per ragioni temporali dovremmo attribuirla a Fletcher, ma visto
che non mancano ai Cugini incongruenze simili a quelle notate nel Racconto
d’inverno, può essere anche toccata a Shakespeare. Comunque, anche se ci
teniamo al minimo, vale a dire il primo e il quinto atto, Shakespeare ha
scritto almeno il quaranta per cento dell’opera e potremmo dire che,
scrivendo le parti tragiche e solenni all’inizio e alla fine, abbia fornito una
solida crosta esterna e di sostegno alla pizza, lasciando a Fletcher il compito