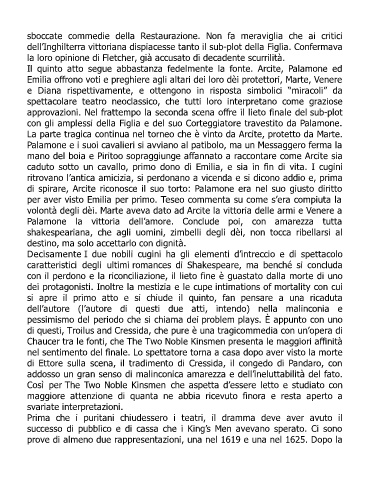Page 1139 - Shakespeare - Vol. 4
P. 1139
sboccate commedie della Restaurazione. Non fa meraviglia che ai critici
dell’Inghilterra vittoriana dispiacesse tanto il sub-plot della Figlia. Confermava
la loro opinione di Fletcher, già accusato di decadente scurrilità.
Il quinto atto segue abbastanza fedelmente la fonte. Arcite, Palamone ed
Emilia offrono voti e preghiere agli altari dei loro dèi protettori, Marte, Venere
e Diana rispettivamente, e ottengono in risposta simbolici “miracoli” da
spettacolare teatro neoclassico, che tutti loro interpretano come graziose
approvazioni. Nel frattempo la seconda scena offre il lieto finale del sub-plot
con gli amplessi della Figlia e del suo Corteggiatore travestito da Palamone.
La parte tragica continua nel torneo che è vinto da Arcite, protetto da Marte.
Palamone e i suoi cavalieri si avviano al patibolo, ma un Messaggero ferma la
mano del boia e Piritoo sopraggiunge affannato a raccontare come Arcite sia
caduto sotto un cavallo, primo dono di Emilia, e sia in fin di vita. I cugini
ritrovano l’antica amicizia, si perdonano a vicenda e si dicono addio e, prima
di spirare, Arcite riconosce il suo torto: Palamone era nel suo giusto diritto
per aver visto Emilia per primo. Teseo commenta su come s’era compiuta la
volontà degli dèi. Marte aveva dato ad Arcite la vittoria delle armi e Venere a
Palamone la vittoria dell’amore. Conclude poi, con amarezza tutta
shakespeariana, che agli uomini, zimbelli degli dèi, non tocca ribellarsi al
destino, ma solo accettarlo con dignità.
Decisamente I due nobili cugini ha gli elementi d’intreccio e di spettacolo
caratteristici degli ultimi romances di Shakespeare, ma benché si concluda
con il perdono e la riconciliazione, il lieto fine è guastato dalla morte di uno
dei protagonisti. Inoltre la mestizia e le cupe intimations of mortality con cui
si apre il primo atto e si chiude il quinto, fan pensare a una ricaduta
dell’autore (l’autore di questi due atti, intendo) nella malinconia e
pessimismo del periodo che si chiama dei problem plays. È appunto con uno
di questi, Troilus and Cressida, che pure è una tragicommedia con un’opera di
Chaucer tra le fonti, che The Two Noble Kinsmen presenta le maggiori affinità
nel sentimento del finale. Lo spettatore torna a casa dopo aver visto la morte
di Ettore sulla scena, il tradimento di Cressida, il congedo di Pandaro, con
addosso un gran senso di malinconica amarezza e dell’ineluttabilità del fato.
Così per The Two Noble Kinsmen che aspetta d’essere letto e studiato con
maggiore attenzione di quanta ne abbia ricevuto finora e resta aperto a
svariate interpretazioni.
Prima che i puritani chiudessero i teatri, il dramma deve aver avuto il
successo di pubblico e di cassa che i King’s Men avevano sperato. Ci sono
prove di almeno due rappresentazioni, una nel 1619 e una nel 1625. Dopo la