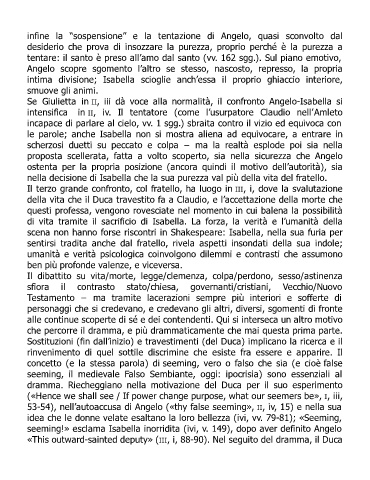Page 923 - Shakespeare - Vol. 3
P. 923
infine la “sospensione” e la tentazione di Angelo, quasi sconvolto dal
desiderio che prova di insozzare la purezza, proprio perché è la purezza a
tentare: il santo è preso all’amo dal santo (vv. 162 sgg.). Sul piano emotivo,
Angelo scopre sgomento l’altro se stesso, nascosto, represso, la propria
intima divisione; Isabella scioglie anch’essa il proprio ghiaccio interiore,
smuove gli animi.
Se Giulietta in II, iii dà voce alla normalità, il confronto Angelo-Isabella si
intensifica in II, iv. Il tentatore (come l’usurpatore Claudio nell’Amleto
incapace di parlare al cielo, vv. 1 sgg.) sbraita contro il vizio ed equivoca con
le parole; anche Isabella non si mostra aliena ad equivocare, a entrare in
scherzosi duetti su peccato e colpa − ma la realtà esplode poi sia nella
proposta scellerata, fatta a volto scoperto, sia nella sicurezza che Angelo
ostenta per la propria posizione (ancora quindi il motivo dell’autorità), sia
nella decisione di Isabella che la sua purezza val più della vita del fratello.
Il terzo grande confronto, col fratello, ha luogo in III, i, dove la svalutazione
della vita che il Duca travestito fa a Claudio, e l’accettazione della morte che
questi professa, vengono rovesciate nel momento in cui balena la possibilità
di vita tramite il sacrificio di Isabella. La forza, la verità e l’umanità della
scena non hanno forse riscontri in Shakespeare: Isabella, nella sua furia per
sentirsi tradita anche dal fratello, rivela aspetti insondati della sua indole;
umanità e verità psicologica coinvolgono dilemmi e contrasti che assumono
ben più profonde valenze, e viceversa.
Il dibattito su vita/morte, legge/clemenza, colpa/perdono, sesso/astinenza
sfiora il contrasto stato/chiesa, governanti/cristiani, Vecchio/Nuovo
Testamento − ma tramite lacerazioni sempre più interiori e sofferte di
personaggi che si credevano, e credevano gli altri, diversi, sgomenti di fronte
alle continue scoperte di sé e dei contendenti. Qui si interseca un altro motivo
che percorre il dramma, e più drammaticamente che mai questa prima parte.
Sostituzioni (fin dall’inizio) e travestimenti (del Duca) implicano la ricerca e il
rinvenimento di quel sottile discrimine che esiste fra essere e apparire. Il
concetto (e la stessa parola) di seeming, vero o falso che sia (e cioè false
seeming, il medievale Falso Sembiante, oggi: ipocrisia) sono essenziali al
dramma. Riecheggiano nella motivazione del Duca per il suo esperimento
(«Hence we shall see / If power change purpose, what our seemers be», I, iii,
53-54), nell’autoaccusa di Angelo («thy false seeming», II, iv, 15) e nella sua
idea che le donne velate esaltano la loro bellezza (ivi, vv. 79-81); «Seeming,
seeming!» esclama Isabella inorridita (ivi, v. 149), dopo aver definito Angelo
«This outward-sainted deputy» (III, i, 88-90). Nel seguito del dramma, il Duca