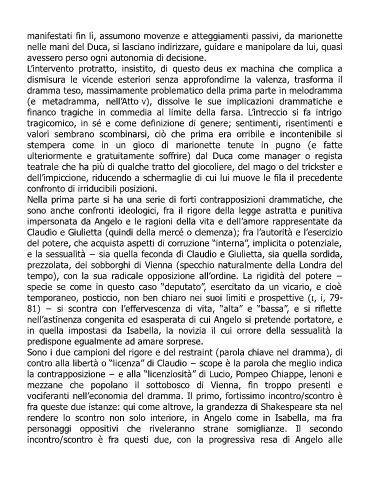Page 921 - Shakespeare - Vol. 3
P. 921
manifestati fin lì, assumono movenze e atteggiamenti passivi, da marionette
nelle mani del Duca, si lasciano indirizzare, guidare e manipolare da lui, quasi
avessero perso ogni autonomia di decisione.
L’intervento protratto, insistito, di questo deus ex machina che complica a
dismisura le vicende esteriori senza approfondirne la valenza, trasforma il
dramma teso, massimamente problematico della prima parte in melodramma
(e metadramma, nell’Atto V), dissolve le sue implicazioni drammatiche e
financo tragiche in commedia al limite della farsa. L’intreccio si fa intrigo
tragicomico, in sé e come definizione di genere; sentimenti, risentimenti e
valori sembrano scombinarsi, ciò che prima era orribile e incontenibile si
stempera come in un gioco di marionette tenute in pugno (e fatte
ulteriormente e gratuitamente soffrire) dal Duca come manager o regista
teatrale che ha più di qualche tratto del giocoliere, del mago o del trickster e
dell’impiccione, riducendo a schermaglie di cui lui muove le fila il precedente
confronto di irriducibili posizioni.
Nella prima parte si ha una serie di forti contrapposizioni drammatiche, che
sono anche confronti ideologici, fra il rigore della legge astratta e punitiva
impersonata da Angelo e le ragioni della vita e dell’amore rappresentate da
Claudio e Giulietta (quindi della mercé o clemenza); fra l’autorità e l’esercizio
del potere, che acquista aspetti di corruzione “interna”, implicita o potenziale,
e la sessualità − sia quella feconda di Claudio e Giulietta, sia quella sordida,
prezzolata, dei sobborghi di Vienna (specchio naturalmente della Londra del
tempo), con la sua radicale opposizione all’ordine. La rigidità del potere −
specie se come in questo caso “deputato”, esercitato da un vicario, e cioè
temporaneo, posticcio, non ben chiaro nei suoi limiti e prospettive (I, i, 79-
81) − si scontra con l’effervescenza di vita, “alta” e “bassa”, e si riflette
nell’astinenza congenita ed esasperata di cui Angelo si pretende portatore, e
in quella impostasi da Isabella, la novizia il cui orrore della sessualità la
predispone egualmente ad amare sorprese.
Sono i due campioni del rigore e del restraint (parola chiave nel dramma), di
contro alla libertà o “licenza” di Claudio − scope è la parola che meglio indica
la contrapposizione − e alla “licenziosità” di Lucio, Pompeo Chiappe, lenoni e
mezzane che popolano il sottobosco di Vienna, fin troppo presenti e
vociferanti nell’economia del dramma. Il primo, fortissimo incontro/scontro è
fra queste due istanze: qui come altrove, la grandezza di Shakespeare sta nel
rendere lo scontro non solo interiore, in Angelo come in Isabella, ma fra
personaggi oppositivi che riveleranno strane somiglianze. Il secondo
incontro/scontro è fra questi due, con la progressiva resa di Angelo alle