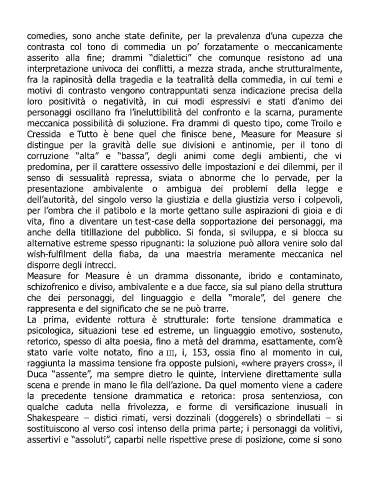Page 920 - Shakespeare - Vol. 3
P. 920
comedies, sono anche state definite, per la prevalenza d’una cupezza che
contrasta col tono di commedia un po’ forzatamente o meccanicamente
asserito alla fine; drammi “dialettici” che comunque resistono ad una
interpretazione univoca dei conflitti, a mezza strada, anche strutturalmente,
fra la rapinosità della tragedia e la teatralità della commedia, in cui temi e
motivi di contrasto vengono contrappuntati senza indicazione precisa della
loro positività o negatività, in cui modi espressivi e stati d’animo dei
personaggi oscillano fra l’ineluttibilità del confronto e la scarna, puramente
meccanica possibilità di soluzione. Fra drammi di questo tipo, come Troilo e
Cressida e Tutto è bene quel che finisce bene, Measure for Measure si
distingue per la gravità delle sue divisioni e antinomie, per il tono di
corruzione “alta” e “bassa”, degli animi come degli ambienti, che vi
predomina, per il carattere ossessivo delle impostazioni e dei dilemmi, per il
senso di sessualità repressa, sviata o abnorme che lo pervade, per la
presentazione ambivalente o ambigua dei problemi della legge e
dell’autorità, del singolo verso la giustizia e della giustizia verso i colpevoli,
per l’ombra che il patibolo e la morte gettano sulle aspirazioni di gioia e di
vita, fino a diventare un test-case della sopportazione dei personaggi, ma
anche della titillazione del pubblico. Si fonda, si sviluppa, e si blocca su
alternative estreme spesso ripugnanti: la soluzione può allora venire solo dal
wish-fulfilment della fiaba, da una maestria meramente meccanica nel
disporre degli intrecci.
Measure for Measure è un dramma dissonante, ibrido e contaminato,
schizofrenico e diviso, ambivalente e a due facce, sia sul piano della struttura
che dei personaggi, del linguaggio e della “morale”, del genere che
rappresenta e del significato che se ne può trarre.
La prima, evidente rottura è strutturale: forte tensione drammatica e
psicologica, situazioni tese ed estreme, un linguaggio emotivo, sostenuto,
retorico, spesso di alta poesia, fino a metà del dramma, esattamente, com’è
stato varie volte notato, fino a III, i, 153, ossia fino al momento in cui,
raggiunta la massima tensione fra opposte pulsioni, «where prayers cross», il
Duca “assente”, ma sempre dietro le quinte, interviene direttamente sulla
scena e prende in mano le fila dell’azione. Da quel momento viene a cadere
la precedente tensione drammatica e retorica: prosa sentenziosa, con
qualche caduta nella frivolezza, e forme di versificazione inusuali in
Shakespeare − distici rimati, versi dozzinali (doggerels) o sbrindellati − si
sostituiscono al verso così intenso della prima parte; i personaggi da volitivi,
assertivi e “assoluti”, caparbi nelle rispettive prese di posizione, come si sono