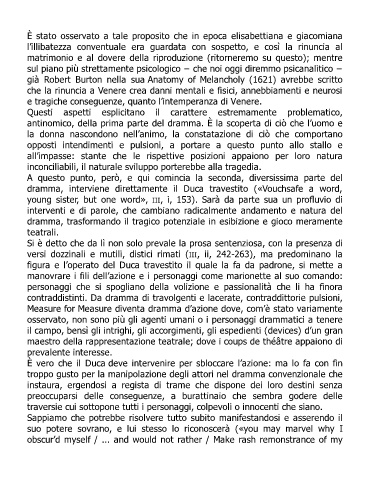Page 925 - Shakespeare - Vol. 3
P. 925
È stato osservato a tale proposito che in epoca elisabettiana e giacomiana
l’illibatezza conventuale era guardata con sospetto, e così la rinuncia al
matrimonio e al dovere della riproduzione (ritorneremo su questo); mentre
sul piano più strettamente psicologico − che noi oggi diremmo psicanalitico −
già Robert Burton nella sua Anatomy of Melancholy (1621) avrebbe scritto
che la rinuncia a Venere crea danni mentali e fisici, annebbiamenti e neurosi
e tragiche conseguenze, quanto l’intemperanza di Venere.
Questi aspetti esplicitano il carattere estremamente problematico,
antinomico, della prima parte del dramma. È la scoperta di ciò che l’uomo e
la donna nascondono nell’animo, la constatazione di ciò che comportano
opposti intendimenti e pulsioni, a portare a questo punto allo stallo e
all’impasse: stante che le rispettive posizioni appaiono per loro natura
inconciliabili, il naturale sviluppo porterebbe alla tragedia.
A questo punto, però, e qui comincia la seconda, diversissima parte del
dramma, interviene direttamente il Duca travestito («Vouchsafe a word,
young sister, but one word», III, i, 153). Sarà da parte sua un profluvio di
interventi e di parole, che cambiano radicalmente andamento e natura del
dramma, trasformando il tragico potenziale in esibizione e gioco meramente
teatrali.
Si è detto che da lì non solo prevale la prosa sentenziosa, con la presenza di
versi dozzinali e mutili, distici rimati (III, ii, 242-263), ma predominano la
figura e l’operato del Duca travestito il quale la fa da padrone, si mette a
manovrare i fili dell’azione e i personaggi come marionette al suo comando:
personaggi che si spogliano della volizione e passionalità che li ha finora
contraddistinti. Da dramma di travolgenti e lacerate, contraddittorie pulsioni,
Measure for Measure diventa dramma d’azione dove, com’è stato variamente
osservato, non sono più gli agenti umani o i personaggi drammatici a tenere
il campo, bensì gli intrighi, gli accorgimenti, gli espedienti (devices) d’un gran
maestro della rappresentazione teatrale; dove i coups de théâtre appaiono di
prevalente interesse.
È vero che il Duca deve intervenire per sbloccare l’azione: ma lo fa con fin
troppo gusto per la manipolazione degli attori nel dramma convenzionale che
instaura, ergendosi a regista di trame che dispone dei loro destini senza
preoccuparsi delle conseguenze, a burattinaio che sembra godere delle
traversie cui sottopone tutti i personaggi, colpevoli o innocenti che siano.
Sappiamo che potrebbe risolvere tutto subito manifestandosi e asserendo il
suo potere sovrano, e lui stesso lo riconoscerà («you may marvel why I
obscur’d myself / ... and would not rather / Make rash remonstrance of my