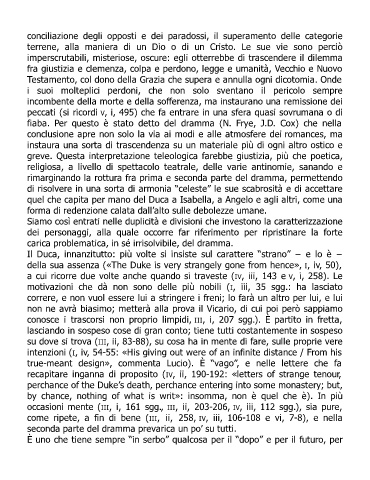Page 929 - Shakespeare - Vol. 3
P. 929
conciliazione degli opposti e dei paradossi, il superamento delle categorie
terrene, alla maniera di un Dio o di un Cristo. Le sue vie sono perciò
imperscrutabili, misteriose, oscure: egli otterrebbe di trascendere il dilemma
fra giustizia e clemenza, colpa e perdono, legge e umanità, Vecchio e Nuovo
Testamento, col dono della Grazia che supera e annulla ogni dicotomia. Onde
i suoi molteplici perdoni, che non solo sventano il pericolo sempre
incombente della morte e della sofferenza, ma instaurano una remissione dei
peccati (si ricordi V, i, 495) che fa entrare in una sfera quasi sovrumana o di
fiaba. Per questo è stato detto del dramma (N. Frye, J.D. Cox) che nella
conclusione apre non solo la via ai modi e alle atmosfere dei romances, ma
instaura una sorta di trascendenza su un materiale più di ogni altro ostico e
greve. Questa interpretazione teleologica farebbe giustizia, più che poetica,
religiosa, a livello di spettacolo teatrale, delle varie antinomie, sanando e
rimarginando la rottura fra prima e seconda parte del dramma, permettendo
di risolvere in una sorta di armonia “celeste” le sue scabrosità e di accettare
quel che capita per mano del Duca a Isabella, a Angelo e agli altri, come una
forma di redenzione calata dall’alto sulle debolezze umane.
Siamo così entrati nelle duplicità e divisioni che investono la caratterizzazione
dei personaggi, alla quale occorre far riferimento per ripristinare la forte
carica problematica, in sé irrisolvibile, del dramma.
Il Duca, innanzitutto: più volte si insiste sul carattere “strano” − e lo è −
della sua assenza («The Duke is very strangely gone from hence», I, iv, 50),
a cui ricorre due volte anche quando si traveste (IV, iii, 143 e V, i, 258). Le
motivazioni che dà non sono delle più nobili (I, iii, 35 sgg.: ha lasciato
correre, e non vuol essere lui a stringere i freni; lo farà un altro per lui, e lui
non ne avrà biasimo; metterà alla prova il Vicario, di cui poi però sappiamo
conosce i trascorsi non proprio limpidi, III, i, 207 sgg.). È partito in fretta,
lasciando in sospeso cose di gran conto; tiene tutti costantemente in sospeso
su dove si trova (III, ii, 83-88), su cosa ha in mente di fare, sulle proprie vere
intenzioni (I, iv, 54-55: «His giving out were of an infinite distance / From his
true-meant design», commenta Lucio). È “vago”, e nelle lettere che fa
recapitare inganna di proposito (IV, ii, 190-192: «letters of strange tenour,
perchance of the Duke’s death, perchance entering into some monastery; but,
by chance, nothing of what is writ»: insomma, non è quel che è). In più
occasioni mente (III, i, 161 sgg., III, ii, 203-206, IV, iii, 112 sgg.), sia pure,
come ripete, a fin di bene (III, ii, 258, IV, iii, 106-108 e vi, 7-8), e nella
seconda parte del dramma prevarica un po’ su tutti.
È uno che tiene sempre “in serbo” qualcosa per il “dopo” e per il futuro, per