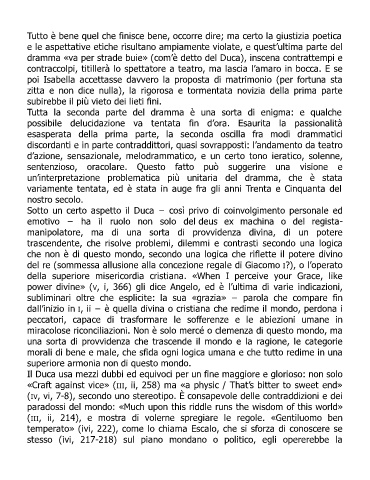Page 928 - Shakespeare - Vol. 3
P. 928
Tutto è bene quel che finisce bene, occorre dire; ma certo la giustizia poetica
e le aspettative etiche risultano ampiamente violate, e quest’ultima parte del
dramma «va per strade buie» (com’è detto del Duca), inscena contrattempi e
contraccolpi, titillerà lo spettatore a teatro, ma lascia l’amaro in bocca. E se
poi Isabella accettasse davvero la proposta di matrimonio (per fortuna sta
zitta e non dice nulla), la rigorosa e tormentata novizia della prima parte
subirebbe il più vieto dei lieti fini.
Tutta la seconda parte del dramma è una sorta di enigma: e qualche
possibile delucidazione va tentata fin d’ora. Esaurita la passionalità
esasperata della prima parte, la seconda oscilla fra modi drammatici
discordanti e in parte contraddittori, quasi sovrapposti: l’andamento da teatro
d’azione, sensazionale, melodrammatico, e un certo tono ieratico, solenne,
sentenzioso, oracolare. Questo fatto può suggerire una visione e
un’interpretazione problematica più unitaria del dramma, che è stata
variamente tentata, ed è stata in auge fra gli anni Trenta e Cinquanta del
nostro secolo.
Sotto un certo aspetto il Duca − così privo di coinvolgimento personale ed
emotivo − ha il ruolo non solo del deus ex machina o del regista-
manipolatore, ma di una sorta di provvidenza divina, di un potere
trascendente, che risolve problemi, dilemmi e contrasti secondo una logica
che non è di questo mondo, secondo una logica che riflette il potere divino
del re (sommessa allusione alla concezione regale di Giacomo I?), o l’operato
della superiore misericordia cristiana. «When I perceive your Grace, like
power divine» (V, i, 366) gli dice Angelo, ed è l’ultima di varie indicazioni,
subliminari oltre che esplicite: la sua «grazia» − parola che compare fin
dall’inizio in I, ii − è quella divina o cristiana che redime il mondo, perdona i
peccatori, capace di trasformare le sofferenze e le abiezioni umane in
miracolose riconciliazioni. Non è solo mercé o clemenza di questo mondo, ma
una sorta di provvidenza che trascende il mondo e la ragione, le categorie
morali di bene e male, che sfida ogni logica umana e che tutto redime in una
superiore armonia non di questo mondo.
Il Duca usa mezzi dubbi ed equivoci per un fine maggiore e glorioso: non solo
«Craft against vice» (III, ii, 258) ma «a physic / That’s bitter to sweet end»
(IV, vi, 7-8), secondo uno stereotipo. È consapevole delle contraddizioni e dei
paradossi del mondo: «Much upon this riddle runs the wisdom of this world»
(III, ii, 214), e mostra di volerne spregiare le regole. «Gentiluomo ben
temperato» (ivi, 222), come lo chiama Escalo, che si sforza di conoscere se
stesso (ivi, 217-218) sul piano mondano o politico, egli opererebbe la