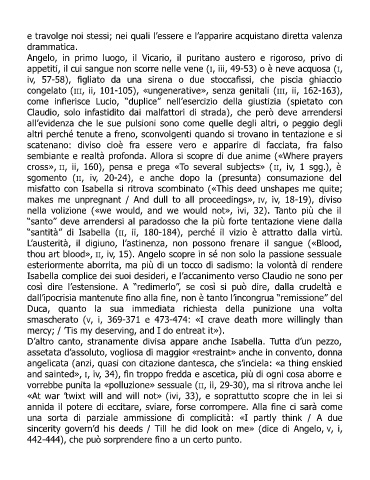Page 931 - Shakespeare - Vol. 3
P. 931
e travolge noi stessi; nei quali l’essere e l’apparire acquistano diretta valenza
drammatica.
Angelo, in primo luogo, il Vicario, il puritano austero e rigoroso, privo di
appetiti, il cui sangue non scorre nelle vene (I, iii, 49-53) o è neve acquosa (I,
iv, 57-58), figliato da una sirena o due stoccafissi, che piscia ghiaccio
congelato (III, ii, 101-105), «ungenerative», senza genitali (III, ii, 162-163),
come infierisce Lucio, “duplice” nell’esercizio della giustizia (spietato con
Claudio, solo infastidito dai malfattori di strada), che però deve arrendersi
all’evidenza che le sue pulsioni sono come quelle degli altri, o peggio degli
altri perché tenute a freno, sconvolgenti quando si trovano in tentazione e si
scatenano: diviso cioè fra essere vero e apparire di facciata, fra falso
sembiante e realtà profonda. Allora si scopre di due anime («Where prayers
cross», II, ii, 160), pensa e prega «To several subjects» ( II, iv, 1 sgg.), è
sgomento (II, iv, 20-24), e anche dopo la (presunta) consumazione del
misfatto con Isabella si ritrova scombinato («This deed unshapes me quite;
makes me unpregnant / And dull to all proceedings», IV, iv, 18-19), diviso
nella volizione («we would, and we would not», ivi, 32). Tanto più che il
“santo” deve arrendersi al paradosso che la più forte tentazione viene dalla
“santità” di Isabella (II, ii, 180-184), perché il vizio è attratto dalla virtù.
L’austerità, il digiuno, l’astinenza, non possono frenare il sangue («Blood,
thou art blood», II, iv, 15). Angelo scopre in sé non solo la passione sessuale
esteriormente aborrita, ma più di un tocco di sadismo: la volontà di rendere
Isabella complice dei suoi desideri, e l’accanimento verso Claudio ne sono per
così dire l’estensione. A “redimerlo”, se così si può dire, dalla crudeltà e
dall’ipocrisia mantenute fino alla fine, non è tanto l’incongrua “remissione” del
Duca, quanto la sua immediata richiesta della punizione una volta
smascherato (V, i, 369-371 e 473-474: «I crave death more willingly than
mercy; / ’Tis my deserving, and I do entreat it»).
D’altro canto, stranamente divisa appare anche Isabella. Tutta d’un pezzo,
assetata d’assoluto, vogliosa di maggior «restraint» anche in convento, donna
angelicata (anzi, quasi con citazione dantesca, che s’inciela: «a thing enskied
and sainted», I, iv, 34), fin troppo fredda e ascetica, più di ogni cosa aborre e
vorrebbe punita la «polluzione» sessuale (II, ii, 29-30), ma si ritrova anche lei
«At war ’twixt will and will not» (ivi, 33), e soprattutto scopre che in lei si
annida il potere di eccitare, sviare, forse corrompere. Alla fine ci sarà come
una sorta di parziale ammissione di complicità: «I partly think / A due
sincerity govern’d his deeds / Till he did look on me» (dice di Angelo, V, i,
442-444), che può sorprendere fino a un certo punto.