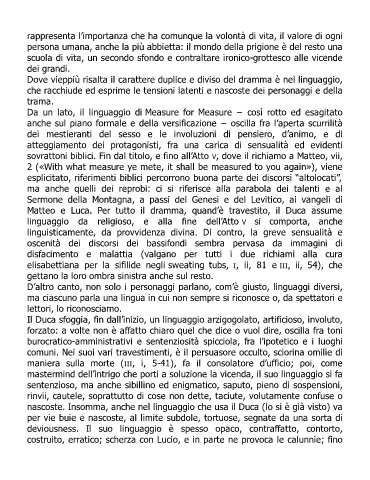Page 935 - Shakespeare - Vol. 3
P. 935
rappresenta l’importanza che ha comunque la volontà di vita, il valore di ogni
persona umana, anche la più abbietta: il mondo della prigione è del resto una
scuola di vita, un secondo sfondo e contraltare ironico-grottesco alle vicende
dei grandi.
Dove vieppiù risalta il carattere duplice e diviso del dramma è nel linguaggio,
che racchiude ed esprime le tensioni latenti e nascoste dei personaggi e della
trama.
Da un lato, il linguaggio di Measure for Measure − così rotto ed esagitato
anche sul piano formale e della versificazione − oscilla fra l’aperta scurrilità
dei mestieranti del sesso e le involuzioni di pensiero, d’animo, e di
atteggiamento dei protagonisti, fra una carica di sensualità ed evidenti
sovrattoni biblici. Fin dal titolo, e fino all’Atto V, dove il richiamo a Matteo, vii,
2 («With what measure ye mete, it shall be measured to you again»), viene
esplicitato, riferimenti biblici percorrono buona parte dei discorsi “altolocati”,
ma anche quelli dei reprobi: ci si riferisce alla parabola dei talenti e al
Sermone della Montagna, a passi del Genesi e del Levitico, ai vangeli di
Matteo e Luca. Per tutto il dramma, quand’è travestito, il Duca assume
linguaggio da religioso, e alla fine dell’Atto V si comporta, anche
linguisticamente, da provvidenza divina. Di contro, la greve sensualità e
oscenità dei discorsi dei bassifondi sembra pervasa da immagini di
disfacimento e malattia (valgano per tutti i due richiami alla cura
elisabettiana per la sifilide negli sweating tubs, I, ii, 81 e III, ii, 54), che
gettano la loro ombra sinistra anche sul resto.
D’altro canto, non solo i personaggi parlano, com’è giusto, linguaggi diversi,
ma ciascuno parla una lingua in cui non sempre si riconosce o, da spettatori e
lettori, lo riconosciamo.
Il Duca sfoggia, fin dall’inizio, un linguaggio arzigogolato, artificioso, involuto,
forzato: a volte non è affatto chiaro quel che dice o vuol dire, oscilla fra toni
burocratico-amministrativi e sentenziosità spicciola, fra l’ipotetico e i luoghi
comuni. Nei suoi vari travestimenti, è il persuasore occulto, sciorina omilie di
maniera sulla morte (III, i, 5-41), fa il consolatore d’ufficio; poi, come
mastermind dell’intrigo che porti a soluzione la vicenda, il suo linguaggio si fa
sentenzioso, ma anche sibillino ed enigmatico, saputo, pieno di sospensioni,
rinvii, cautele, soprattutto di cose non dette, taciute, volutamente confuse o
nascoste. Insomma, anche nel linguaggio che usa il Duca (lo si è già visto) va
per vie buie e nascoste, al limite subdole, tortuose, segnate da una sorta di
deviousness. Il suo linguaggio è spesso opaco, contraffatto, contorto,
costruito, erratico; scherza con Lucio, e in parte ne provoca le calunnie; fino