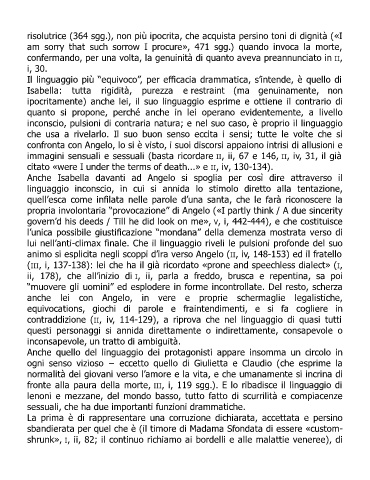Page 937 - Shakespeare - Vol. 3
P. 937
risolutrice (364 sgg.), non più ipocrita, che acquista persino toni di dignità («I
am sorry that such sorrow I procure», 471 sgg.) quando invoca la morte,
confermando, per una volta, la genuinità di quanto aveva preannunciato in II,
i, 30.
Il linguaggio più “equivoco”, per efficacia drammatica, s’intende, è quello di
Isabella: tutta rigidità, purezza e restraint (ma genuinamente, non
ipocritamente) anche lei, il suo linguaggio esprime e ottiene il contrario di
quanto si propone, perché anche in lei operano evidentemente, a livello
inconscio, pulsioni di contraria natura; e nel suo caso, è proprio il linguaggio
che usa a rivelarlo. Il suo buon senso eccita i sensi; tutte le volte che si
confronta con Angelo, lo si è visto, i suoi discorsi appaiono intrisi di allusioni e
immagini sensuali e sessuali (basta ricordare II, ii, 67 e 146, II, iv, 31, il già
citato «were I under the terms of death...» e II, iv, 130-134).
Anche Isabella davanti ad Angelo si spoglia per così dire attraverso il
linguaggio inconscio, in cui si annida lo stimolo diretto alla tentazione,
quell’esca come infilata nelle parole d’una santa, che le farà riconoscere la
propria involontaria “provocazione” di Angelo («I partly think / A due sincerity
govern’d his deeds / Till he did look on me», V, i, 442-444), e che costituisce
l’unica possibile giustificazione “mondana” della clemenza mostrata verso di
lui nell’anti-climax finale. Che il linguaggio riveli le pulsioni profonde del suo
animo si esplicita negli scoppi d’ira verso Angelo (II, iv, 148-153) ed il fratello
(III, i, 137-138): lei che ha il già ricordato «prone and speechless dialect» (I,
ii, 178), che all’inizio di I, ii, parla a freddo, brusca e repentina, sa poi
“muovere gli uomini” ed esplodere in forme incontrollate. Del resto, scherza
anche lei con Angelo, in vere e proprie schermaglie legalistiche,
equivocations, giochi di parole e fraintendimenti, e si fa cogliere in
contraddizione (II, iv, 114-129), a riprova che nel linguaggio di quasi tutti
questi personaggi si annida direttamente o indirettamente, consapevole o
inconsapevole, un tratto di ambiguità.
Anche quello del linguaggio dei protagonisti appare insomma un circolo in
ogni senso vizioso − eccetto quello di Giulietta e Claudio (che esprime la
normalità dei giovani verso l’amore e la vita, e che umanamente si incrina di
fronte alla paura della morte, III, i, 119 sgg.). E lo ribadisce il linguaggio di
lenoni e mezzane, del mondo basso, tutto fatto di scurrilità e compiacenze
sessuali, che ha due importanti funzioni drammatiche.
La prima è di rappresentare una corruzione dichiarata, accettata e persino
sbandierata per quel che è (il timore di Madama Sfondata di essere «custom-
shrunk», I, ii, 82; il continuo richiamo ai bordelli e alle malattie veneree), di