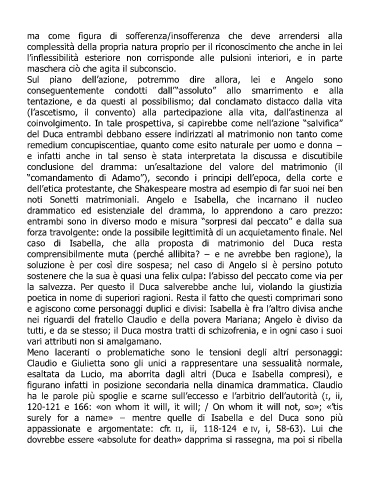Page 933 - Shakespeare - Vol. 3
P. 933
ma come figura di sofferenza/insofferenza che deve arrendersi alla
complessità della propria natura proprio per il riconoscimento che anche in lei
l’inflessibilità esteriore non corrisponde alle pulsioni interiori, e in parte
maschera ciò che agita il subconscio.
Sul piano dell’azione, potremmo dire allora, lei e Angelo sono
conseguentemente condotti dall’“assoluto” allo smarrimento e alla
tentazione, e da questi al possibilismo; dal conclamato distacco dalla vita
(l’ascetismo, il convento) alla partecipazione alla vita, dall’astinenza al
coinvolgimento. In tale prospettiva, si capirebbe come nell’azione “salvifica”
del Duca entrambi debbano essere indirizzati al matrimonio non tanto come
remedium concupiscentiae, quanto come esito naturale per uomo e donna −
e infatti anche in tal senso è stata interpretata la discussa e discutibile
conclusione del dramma: un’esaltazione del valore del matrimonio (il
“comandamento di Adamo”), secondo i principi dell’epoca, della corte e
dell’etica protestante, che Shakespeare mostra ad esempio di far suoi nei ben
noti Sonetti matrimoniali. Angelo e Isabella, che incarnano il nucleo
drammatico ed esistenziale del dramma, lo apprendono a caro prezzo:
entrambi sono in diverso modo e misura “sorpresi dal peccato” e dalla sua
forza travolgente: onde la possibile legittimità di un acquietamento finale. Nel
caso di Isabella, che alla proposta di matrimonio del Duca resta
comprensibilmente muta (perché allibita? − e ne avrebbe ben ragione), la
soluzione è per così dire sospesa; nel caso di Angelo si è persino potuto
sostenere che la sua è quasi una felix culpa: l’abisso del peccato come via per
la salvezza. Per questo il Duca salverebbe anche lui, violando la giustizia
poetica in nome di superiori ragioni. Resta il fatto che questi comprimari sono
e agiscono come personaggi duplici e divisi: Isabella è fra l’altro divisa anche
nei riguardi del fratello Claudio e della povera Mariana; Angelo è diviso da
tutti, e da se stesso; il Duca mostra tratti di schizofrenia, e in ogni caso i suoi
vari attributi non si amalgamano.
Meno laceranti o problematiche sono le tensioni degli altri personaggi:
Claudio e Giulietta sono gli unici a rappresentare una sessualità normale,
esaltata da Lucio, ma aborrita dagli altri (Duca e Isabella compresi), e
figurano infatti in posizione secondaria nella dinamica drammatica. Claudio
ha le parole più spoglie e scarne sull’eccesso e l’arbitrio dell’autorità (I, ii,
120-121 e 166: «on whom it will, it will; / On whom it will not, so»; «’tis
surely for a name» − mentre quelle di Isabella e del Duca sono più
appassionate e argomentate: cfr. II, ii, 118-124 e IV, i, 58-63). Lui che
dovrebbe essere «absolute for death» dapprima si rassegna, ma poi si ribella