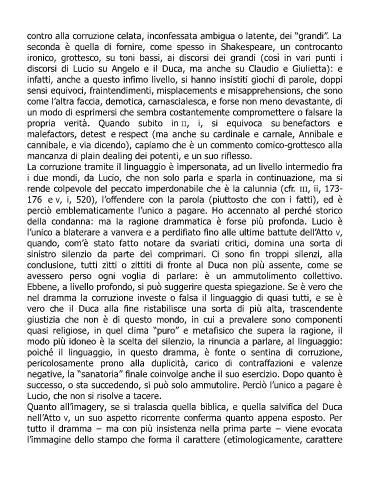Page 938 - Shakespeare - Vol. 3
P. 938
contro alla corruzione celata, inconfessata ambigua o latente, dei “grandi”. La
seconda è quella di fornire, come spesso in Shakespeare, un controcanto
ironico, grottesco, su toni bassi, ai discorsi dei grandi (così in vari punti i
discorsi di Lucio su Angelo e il Duca, ma anche su Claudio e Giulietta): e
infatti, anche a questo infimo livello, si hanno insistiti giochi di parole, doppi
sensi equivoci, fraintendimenti, misplacements e misapprehensions, che sono
come l’altra faccia, demotica, carnascialesca, e forse non meno devastante, di
un modo di esprimersi che sembra costantemente compromettere o falsare la
propria verità. Quando subito in II, i, si equivoca su benefactors e
malefactors, detest e respect (ma anche su cardinale e carnale, Annibale e
cannibale, e via dicendo), capiamo che è un commento comico-grottesco alla
mancanza di plain dealing dei potenti, e un suo riflesso.
La corruzione tramite il linguaggio è impersonata, ad un livello intermedio fra
i due mondi, da Lucio, che non solo parla e sparla in continuazione, ma si
rende colpevole del peccato imperdonabile che è la calunnia (cfr. III, ii, 173-
176 e V, i, 520), l’offendere con la parola (piuttosto che con i fatti), ed è
perciò emblematicamente l’unico a pagare. Ho accennato al perché storico
della condanna: ma la ragione drammatica è forse più profonda. Lucio è
l’unico a blaterare a vanvera e a perdifiato fino alle ultime battute dell’Atto V,
quando, com’è stato fatto notare da svariati critici, domina una sorta di
sinistro silenzio da parte dei comprimari. Ci sono fin troppi silenzi, alla
conclusione, tutti zitti o zittiti di fronte al Duca non più assente, come se
avessero perso ogni voglia di parlare: è un ammutolimento collettivo.
Ebbene, a livello profondo, si può suggerire questa spiegazione. Se è vero che
nel dramma la corruzione investe o falsa il linguaggio di quasi tutti, e se è
vero che il Duca alla fine ristabilisce una sorta di più alta, trascendente
giustizia che non è di questo mondo, in cui a prevalere sono componenti
quasi religiose, in quel clima “puro” e metafisico che supera la ragione, il
modo più idoneo è la scelta del silenzio, la rinuncia a parlare, al linguaggio:
poiché il linguaggio, in questo dramma, è fonte o sentina di corruzione,
pericolosamente prono alla duplicità, carico di contraffazioni e valenze
negative, la “sanatoria” finale coinvolge anche il suo esercizio. Dopo quanto è
successo, o sta succedendo, si può solo ammutolire. Perciò l’unico a pagare è
Lucio, che non si risolve a tacere.
Quanto all’imagery, se si tralascia quella biblica, e quella salvifica del Duca
nell’Atto V, un suo aspetto ricorrente conferma quanto appena esposto. Per
tutto il dramma − ma con più insistenza nella prima parte − viene evocata
l’immagine dello stampo che forma il carattere (etimologicamente, carattere