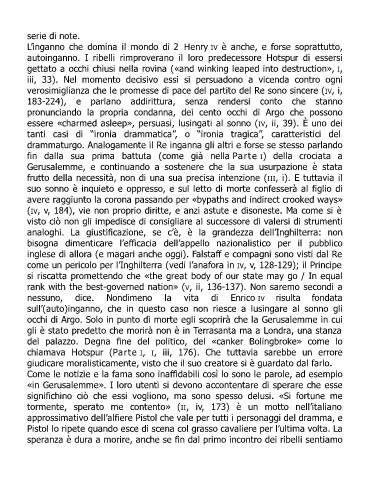Page 827 - Shakespeare - Vol. 2
P. 827
serie di note.
L’inganno che domina il mondo di 2 Henry IV è anche, e forse soprattutto,
autoinganno. I ribelli rimproverano il loro predecessore Hotspur di essersi
gettato a occhi chiusi nella rovina («and winking leaped into destruction», I,
iii, 33). Nel momento decisivo essi si persuadono a vicenda contro ogni
verosimiglianza che le promesse di pace del partito del Re sono sincere (IV, i,
183-224), e parlano addirittura, senza rendersi conto che stanno
pronunciando la propria condanna, dei cento occhi di Argo che possono
essere «charmed asleep», persuasi, lusingati al sonno (IV, ii, 39). È uno dei
tanti casi di “ironia drammatica”, o “ironia tragica”, caratteristici del
drammaturgo. Analogamente il Re inganna gli altri e forse se stesso parlando
fin dalla sua prima battuta (come già nella Parte I) della crociata a
Gerusalemme, e continuando a sostenere che la sua usurpazione è stata
frutto della necessità, non di una sua precisa intenzione (III, i). E tuttavia il
suo sonno è inquieto e oppresso, e sul letto di morte confesserà al figlio di
avere raggiunto la corona passando per «bypaths and indirect crooked ways»
(IV, v, 184), vie non proprio diritte, e anzi astute e disoneste. Ma come si è
visto ciò non gli impedisce di consigliare al successore di valersi di strumenti
analoghi. La giustificazione, se c’è, è la grandezza dell’Inghilterra: non
bisogna dimenticare l’efficacia dell’appello nazionalistico per il pubblico
inglese di allora (e magari anche oggi). Falstaff e compagni sono visti dal Re
come un pericolo per l’Inghilterra (vedi l’anafora in IV, v, 128-129); il Principe
si riscatta promettendo che «the great body of our state may go / In equal
rank with the best-governed nation» (V, ii, 136-137). Non saremo secondi a
nessuno, dice. Nondimeno la vita di Enrico IV risulta fondata
sull’(auto)inganno, che in questo caso non riesce a lusingare al sonno gli
occhi di Argo. Solo in punto di morte egli scoprirà che la Gerusalemme in cui
gli è stato predetto che morirà non è in Terrasanta ma a Londra, una stanza
del palazzo. Degna fine del politico, del «canker Bolingbroke» come lo
chiamava Hotspur (Parte I, I, iii, 176). Che tuttavia sarebbe un errore
giudicare moralisticamente, visto che il suo creatore si è guardato dal farlo.
Come le notizie e la fama sono inaffidabili così lo sono le parole, ad esempio
«in Gerusalemme». I loro utenti si devono accontentare di sperare che esse
significhino ciò che essi vogliono, ma sono spesso delusi. «Si fortune me
tormente, sperato me contento» (II, iv, 173) è un motto nell’italiano
approssimativo dell’alfiere Pistol che vale per tutti i personaggi del dramma, e
Pistol lo ripete quando esce di scena col grasso cavaliere per l’ultima volta. La
speranza è dura a morire, anche se fin dal primo incontro dei ribelli sentiamo