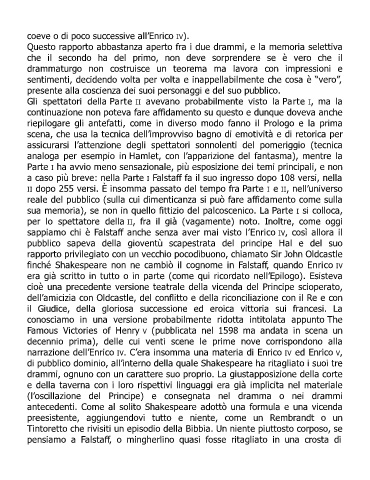Page 824 - Shakespeare - Vol. 2
P. 824
coeve o di poco successive all’Enrico IV).
Questo rapporto abbastanza aperto fra i due drammi, e la memoria selettiva
che il secondo ha del primo, non deve sorprendere se è vero che il
drammaturgo non costruisce un teorema ma lavora con impressioni e
sentimenti, decidendo volta per volta e inappellabilmente che cosa è “vero”,
presente alla coscienza dei suoi personaggi e del suo pubblico.
Gli spettatori della Parte II avevano probabilmente visto la Parte I, ma la
continuazione non poteva fare affidamento su questo e dunque doveva anche
riepilogare gli antefatti, come in diverso modo fanno il Prologo e la prima
scena, che usa la tecnica dell’improvviso bagno di emotività e di retorica per
assicurarsi l’attenzione degli spettatori sonnolenti del pomeriggio (tecnica
analoga per esempio in Hamlet, con l’apparizione del fantasma), mentre la
Parte I ha avvio meno sensazionale, più esposizione dei temi principali, e non
a caso più breve: nella Parte I Falstaff fa il suo ingresso dopo 108 versi, nella
II dopo 255 versi. È insomma passato del tempo fra Parte I e II, nell’universo
reale del pubblico (sulla cui dimenticanza si può fare affidamento come sulla
sua memoria), se non in quello fittizio del palcoscenico. La Parte I si colloca,
per lo spettatore della II, fra il già (vagamente) noto. Inoltre, come oggi
sappiamo chi è Falstaff anche senza aver mai visto l’Enrico IV, così allora il
pubblico sapeva della gioventù scapestrata del principe Hal e del suo
rapporto privilegiato con un vecchio pocodibuono, chiamato Sir John Oldcastle
finché Shakespeare non ne cambiò il cognome in Falstaff, quando Enrico IV
era già scritto in tutto o in parte (come qui ricordato nell’Epilogo). Esisteva
cioè una precedente versione teatrale della vicenda del Principe scioperato,
dell’amicizia con Oldcastle, del conflitto e della riconciliazione con il Re e con
il Giudice, della gloriosa successione ed eroica vittoria sui francesi. La
conosciamo in una versione probabilmente ridotta intitolata appunto The
Famous Victories of Henry V (pubblicata nel 1598 ma andata in scena un
decennio prima), delle cui venti scene le prime nove corrispondono alla
narrazione dell’Enrico IV. C’era insomma una materia di Enrico IV ed Enrico V,
di pubblico dominio, all’interno della quale Shakespeare ha ritagliato i suoi tre
drammi, ognuno con un carattere suo proprio. La giustapposizione della corte
e della taverna con i loro rispettivi linguaggi era già implicita nel materiale
(l’oscillazione del Principe) e consegnata nel dramma o nei drammi
antecedenti. Come al solito Shakespeare adottò una formula e una vicenda
preesistente, aggiungendovi tutto e niente, come un Rembrandt o un
Tintoretto che rivisiti un episodio della Bibbia. Un niente piuttosto corposo, se
pensiamo a Falstaff, o mingherlino quasi fosse ritagliato in una crosta di