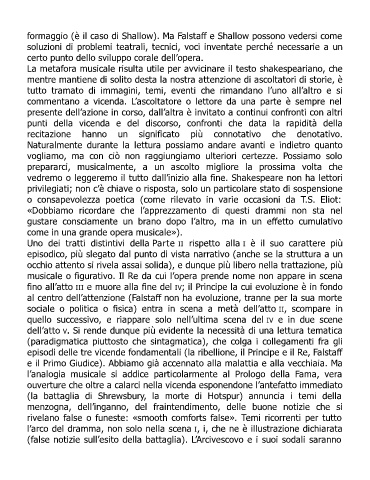Page 825 - Shakespeare - Vol. 2
P. 825
formaggio (è il caso di Shallow). Ma Falstaff e Shallow possono vedersi come
soluzioni di problemi teatrali, tecnici, voci inventate perché necessarie a un
certo punto dello sviluppo corale dell’opera.
La metafora musicale risulta utile per avvicinare il testo shakespeariano, che
mentre mantiene di solito desta la nostra attenzione di ascoltatori di storie, è
tutto tramato di immagini, temi, eventi che rimandano l’uno all’altro e si
commentano a vicenda. L’ascoltatore o lettore da una parte è sempre nel
presente dell’azione in corso, dall’altra è invitato a continui confronti con altri
punti della vicenda e del discorso, confronti che data la rapidità della
recitazione hanno un significato più connotativo che denotativo.
Naturalmente durante la lettura possiamo andare avanti e indietro quanto
vogliamo, ma con ciò non raggiungiamo ulteriori certezze. Possiamo solo
prepararci, musicalmente, a un ascolto migliore la prossima volta che
vedremo o leggeremo il tutto dall’inizio alla fine. Shakespeare non ha lettori
privilegiati; non c’è chiave o risposta, solo un particolare stato di sospensione
o consapevolezza poetica (come rilevato in varie occasioni da T.S. Eliot:
«Dobbiamo ricordare che l’apprezzamento di questi drammi non sta nel
gustare consciamente un brano dopo l’altro, ma in un effetto cumulativo
come in una grande opera musicale»).
Uno dei tratti distintivi della Parte II rispetto alla I è il suo carattere più
episodico, più slegato dal punto di vista narrativo (anche se la struttura a un
occhio attento si rivela assai solida), e dunque più libero nella trattazione, più
musicale o figurativo. Il Re da cui l’opera prende nome non appare in scena
fino all’atto III e muore alla fine del IV; il Principe la cui evoluzione è in fondo
al centro dell’attenzione (Falstaff non ha evoluzione, tranne per la sua morte
sociale o politica o fisica) entra in scena a metà dell’atto II, scompare in
quello successivo, e riappare solo nell’ultima scena del IV e in due scene
dell’atto V. Si rende dunque più evidente la necessità di una lettura tematica
(paradigmatica piuttosto che sintagmatica), che colga i collegamenti fra gli
episodi delle tre vicende fondamentali (la ribellione, il Principe e il Re, Falstaff
e il Primo Giudice). Abbiamo già accennato alla malattia e alla vecchiaia. Ma
l’analogia musicale si addice particolarmente al Prologo della Fama, vera
ouverture che oltre a calarci nella vicenda esponendone l’antefatto immediato
(la battaglia di Shrewsbury, la morte di Hotspur) annuncia i temi della
menzogna, dell’inganno, del fraintendimento, delle buone notizie che si
rivelano false o funeste: «smooth comforts false». Temi ricorrenti per tutto
l’arco del dramma, non solo nella scena I, i, che ne è illustrazione dichiarata
(false notizie sull’esito della battaglia). L’Arcivescovo e i suoi sodali saranno