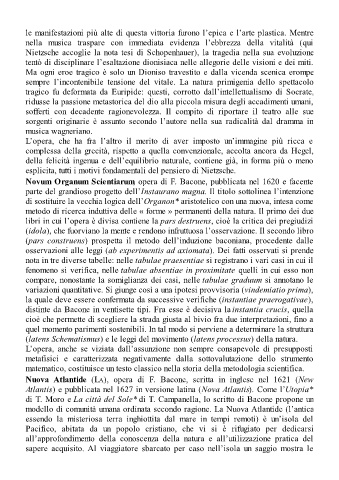Page 941 - Dizionario di Filosofia
P. 941
le manifestazioni più alte di questa vittoria furono l’epica e l’arte plastica. Mentre
nella musica traspare con immediata evidenza l’ebbrezza della vitalità (qui
Nietzsche accoglie la nota tesi di Schopenhauer), la tragedia nella sua evoluzione
tentò di disciplinare l’esaltazione dionisiaca nelle allegorie delle visioni e dei miti.
Ma ogni eroe tragico è solo un Dioniso travestito e dalla vicenda scenica erompe
sempre l’incontenibile tensione del vitale. La natura primigenia dello spettacolo
tragico fu deformata da Euripide: questi, corrotto dall’intellettualismo di Socrate,
ridusse la passione metastorica del dio alla piccola misura degli accadimenti umani,
sofferti con decadente ragionevolezza. Il compito di riportare il teatro alle sue
sorgenti originarie è assunto secondo l’autore nella sua radicalità dal dramma in
musica wagneriano.
L’opera, che ha fra l’altro il merito di aver imposto un’immagine più ricca e
complessa della grecità, rispetto a quella convenzionale, accolta ancora da Hegel,
della felicità ingenua e dell’equilibrio naturale, contiene già, in forma più o meno
esplicita, tutti i motivi fondamentali del pensiero di Nietzsche.
Novum Organum Scientiarum, opera di F. Bacone, pubblicata nel 1620 e facente
parte del grandioso progetto dell’Instaurano magna. Il titolo sottolinea l’intenzione
di sostituire la vecchia logica dell’Organon* aristotelico con una nuova, intesa come
metodo di ricerca induttiva delle « forme » permanenti della natura. Il primo dei due
libri in cui l’opera è divisa contiene la pars destruens, cioè la critica dei pregiudizi
(idola), che fuorviano la mente e rendono infruttuosa l’osservazione. Il secondo libro
(pars construens) prospetta il metodo dell’induzione baconiana, procedente dalle
osservazioni alle leggi (ab experimentis ad axiomata). Dei fatti osservati si prende
nota in tre diverse tabelle: nelle tabulae praesentiae si registrano i vari casi in cui il
fenomeno si verifica, nelle tabulae absentiae in proximitate quelli in cui esso non
compare, nonostante la somiglianza dei casi, nelle tabulae graduum si annotano le
variazioni quantitative. Si giunge così a una ipotesi provvisoria (vindemiatio prima),
la quale deve essere confermata da successive verifiche (instantiae praerogativae),
distinte da Bacone in ventisette tipi. Fra esse è decisiva la instantia crucis, quella
cioè che permette di scegliere la strada giusta al bivio fra due interpretazioni, fino a
quel momento parimenti sostenibili. In tal modo si perviene a determinare la struttura
(latens Schematismus) e le leggi del movimento (latens processus) della natura.
L’opera, anche se viziata dall’assunzione non sempre consapevole di presupposti
metafisici e caratterizzata negativamente dalla sottovalutazione dello strumento
matematico, costituisce un testo classico nella storia della metodologia scientifica.
Nuova Atlantide (LA), opera di F. Bacone, scritta in inglese nel 1621 (New
Atlantis) e pubblicata nel 1627 in versione latina (Nova Atlantis). Come l’Utopia*
di T. Moro e La città del Sole* di T. Campanella, lo scritto di Bacone propone un
modello di comunità umana ordinata secondo ragione. La Nuova Atlantide (l’antica
essendo la misteriosa terra inghiottita dal mare in tempi remoti) è un’isola del
Pacifico, abitata da un popolo cristiano, che vi si è rifugiato per dedicarsi
all’approfondimento della conoscenza della natura e all’utilizzazione pratica del
sapere acquisito. Al viaggiatore sbarcato per caso nell’isola un saggio mostra le