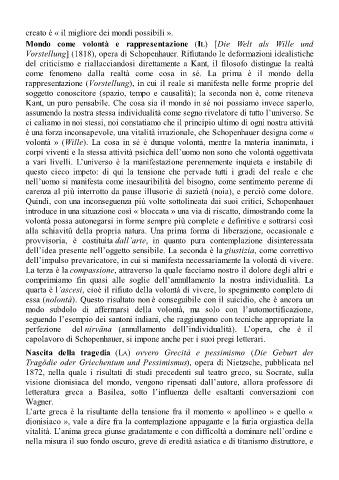Page 940 - Dizionario di Filosofia
P. 940
creato è « il migliore dei mondi possibili ».
Mondo come volontà e rappresentazione (IL) [Die Welt als Wille und
Vorstellung] (1818), opera di Schopenhauer. Rifiutando le deformazioni idealistiche
del criticismo e riallacciandosi direttamente a Kant, il filosofo distingue la realtà
come fenomeno dalla realtà come cosa in sé. La prima è il mondo della
rappresentazione (Vorstellung), in cui il reale si manifesta nelle forme proprie del
soggetto conoscitore (spazio, tempo e causalità); la seconda non è, come riteneva
Kant, un puro pensabile. Che cosa sia il mondo in sé noi possiamo invece saperlo,
assumendo la nostra stessa individualità come segno rivelatore di tutto l’universo. Se
ci caliamo in noi stessi, noi constatiamo che il principio ultimo di ogni nostra attività
è una forza inconsapevole, una vitalità irrazionale, che Schopenhauer designa come «
volontà » (Wille). La cosa in sé è dunque volontà, mentre la materia inanimata, i
corpi viventi e la stessa attività psichica dell’uomo non sono che volontà oggettivata
a vari livelli. L’universo è la manifestazione perennemente inquieta e instabile di
questo cieco impeto: di qui la tensione che pervade tutti i gradi del reale e che
nell’uomo si manifesta come inesauribilità del bisogno, come sentimento perenne di
carenza al più interrotto da pause illusorie di sazietà (noia), e perciò come dolore.
Quindi, con una inconseguenza più volte sottolineata dai suoi critici, Schopenhauer
introduce in una situazione così « bloccata » una via di riscatto, dimostrando come la
volontà possa autonegarsi in forme sempre più complete e definitive e sottrarsi così
alla schiavitû della propria natura. Una prima forma di liberazione, occasionale e
provvisoria, è costituita dall’arte, in quanto pura contemplazione disinteressata
dell’idea presente nell’oggetto sensibile. La seconda è la giustizia, come correttivo
dell’impulso prevaricatore, in cui si manifesta necessariamente la volontà di vivere.
La terza è la compassione, attraverso la quale facciamo nostro il dolore degli altri e
comprimiamo fin quasi alle soglie dell’annullamento la nostra individualità. La
quarta è l’ascesi, cioè il rifiuto della volontà di vivere, lo spegnimento completo di
essa (nolontà). Questo risultato non è conseguibile con il suicidio, che è ancora un
modo subdolo di affermarsi della volontà, ma solo con l’automortificazione,
seguendo l’esempio dei santoni indiani, che raggiungono con tecniche appropriate la
perfezione del nirvāna (annullamento dell’individualità). L’opera, che è il
capolavoro di Schopenhauer, si impone anche per i suoi pregi letterari.
Nascita della tragedia (LA) ovvero Grecità e pessimismo (Die Geburt der
Tragödie oder Griechentum und Pessimismus), opera di Nietzsche, pubblicata nel
1872, nella quale i risultati di studi precedenti sul teatro greco, su Socrate, sulla
visione dionisiaca del mondo, vengono ripensati dall’autore, allora professore di
letteratura greca a Basilea, sotto l’influenza delle esaltanti conversazioni con
Wagner.
L’arte greca è la risultante della tensione fra il momento « apollineo » e quello «
dionisiaco », vale a dire fra la contemplazione appagante e la furia orgiastica della
vitalità. L’anima greca giunse gradatamente e con difficoltà a dominare nell’ordine e
nella misura il suo fondo oscuro, greve di eredità asiatica e di titanismo distruttore, e