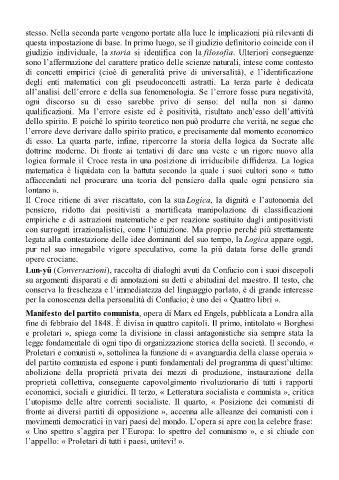Page 935 - Dizionario di Filosofia
P. 935
stesso. Nella seconda parte vengono portate alla luce le implicazioni più rilevanti di
questa impostazione di base. In primo luogo, se il giudizio definitorio coincide con il
giudizio individuale, la storia si identifica con la filosofia. Ulteriori conseguenze
sono l’affermazione del carattere pratico delle scienze naturali, intese come contesto
di concetti empirici (cioè di generalità prive di universalità), e l’identificazione
degli enti matematici con gli pseudoconcetti astratti. La terza parte è dedicata
all’analisi dell’errore e della sua fenomenologia. Se l’errore fosse pura negatività,
ogni discorso su di esso sarebbe privo di senso: del nulla non si danno
qualificazioni. Ma l’errore esiste ed è positività, risultato anch’esso dell’attività
dello spirito. E poiché lo spirito teoretico non può produrre che verità, ne segue che
l’errore deve derivare dallo spirito pratico, e precisamente dal momento economico
di esso. La quarta parte, infine, ripercorre la storia della logica da Socrate alle
dottrine moderne. Di fronte ai tentativi di dare una veste e un rigore nuovo alla
logica formale il Croce resta in una posizione di irriducibile diffidenza. La logica
matematica è liquidata con la battuta secondo la quale i suoi cultori sono « tutto
affaccendati nel procurare una teoria del pensiero dalla quale ogni pensiero sia
lontano ».
Il Croce ritiene di aver riscattato, con la sua Logica, la dignità e l’autonomia del
pensiero, ridotto dai positivisti a mortificata manipolazione di classificazioni
empiriche e di astrazioni matematiche e per reazione sostituito dagli antipositivisti
con surrogati irrazionalistici, come l’intuizione. Ma proprio perché più strettamente
legata alla contestazione delle idee dominanti del suo tempo, la Logica appare oggi,
pur nel suo innegabile vigore speculativo, come la più datata forse delle grandi
opere crociane.
Lun-yü (Conversazioni), raccolta di dialoghi avuti da Confucio con i suoi discepoli
su argomenti disparati e di annotazioni su detti e abitudini del maestro. Il testo, che
conserva la freschezza e l’immediatezza del linguaggio parlato, è di grande interesse
per la conoscenza della personalità di Confucio; è uno dei « Quattro libri ».
Manifesto del partito comunista, opera di Marx ed Engels, pubblicata a Londra alla
fine di febbraio del 1848. È divisa in quattro capitoli. Il primo, intitolato « Borghesi
e proletari », spiega come la divisione in classi antagonistiche sia sempre stata la
legge fondamentale di ogni tipo di organizzazione storica della società. Il secondo, «
Proletari e comunisti », sottolinea la funzione di « avanguardia della classe operaia »
del partito comunista ed espone i punti fondamentali del programma di quest’ultimo:
abolizione della proprietà privata dei mezzi di produzione, instaurazione della
proprietà collettiva, conseguente capovolgimento rivoluzionario di tutti i rapporti
economici, sociali e giuridici. Il terzo, « Letteratura socialista e comunista », critica
l’utopismo delle altre correnti socialiste. Il quarto, « Posizione dei comunisti di
fronte ai diversi partiti di opposizione », accenna alle alleanze dei comunisti con i
movimenti democratici in vari paesi del mondo. L’opera si apre con la celebre frase:
« Uno spettro s’aggira per l’Europa: lo spettro del comunismo », e si chiude con
l’appello: « Proletari di tutti i paesi, unitevi! ».